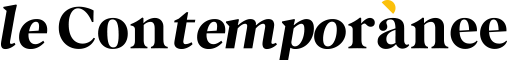Secondo l’Oms, quasi 1 miliardo di persone nel mondo vive con almeno un disturbo psichico (una persona su dieci a livello globale), con un incremento di oltre il 25% dopo la pandemia da Covid 19.
Eppure, il nostro Paese si colloca fra gli ultimi posti in Europa in relazione alla spesa sanitaria dedicata alla salute mentale, destinandovi solo il 3,4% della quota complessiva, laddove i principali Paesi ad alto reddito ne dedicano più del 10%.
Ne consegue che, troppo spesso, chi non sia in possesso delle risorse necessarie rinunci a prendersi cura di un aspetto così fondamentale all’interno della propria vita.
Il trionfo di Simone Biles alle Olimpiadi di Parigi ha tuttavia contribuito a riaccendere l’attenzione collettiva intorno all’importanza di un tema che troppo spesso viene relegato ad una posizione di minorità.
“Dobbiamo proteggere la nostra mente ed il nostro corpo, piuttosto che andare là fuori e fare ad ogni costo quello che il mondo vuole che facciamo.”– Aveva spiegato la ginnasta nel 2020, dopo aver rinunciato alle Olimpiadi estive di Tokyo a causa dei cosiddetti “twisties”, deficit improvvisi di propriocezione indotti da un blocco mentale, esacerbato da stress ed ansia.
Ma ad oggi, davvero lo stigma che circonda i disturbi psichici si può considerare abbattuto?
Questa è la storia di “quel posto al buio”, raccontata da una persona che, in una pendolarità di “andate e di ritorni”, dolorosamente, lo abita.
“Del buco nero ti accorgi per la prima volta quando sei bambino, e guardi il pezzo di cemento che racchiude tre garage dalla finestra dell’unica stanza da letto in casa di tua nonna, dove vivi, da quando tuo padre, il mal del secolo, se l’è portato via.
Ti prende una cosa strana, che non sai definire: e poi fa caldo, troppo caldo: ti sudano le mani, hai paura; ma non sai bene di che cosa; senti un peso dentro al petto…
Ma poi, per fortuna, si richiude. Perché è ancora acerbo, retrattile, come il buco nell’ozono; che se ci si sta attenti può giusto migliorare un po’, e lo fa, grazie ai pensieri volatili che si hanno sempre, da bambini.
Il buco nero torna quando hai quattordici anni, e ti convinci che stai soffocando, anche se non è vero. E quando ne hai ventuno, ed inizi a stare male; anzi, malissimo, dentro ad un centro affitti, con un’amica che poi ti odierà, perché crede che tu voglia escluderla dalla tua vita. Ma è il buco nero che sceglie chi fare entrare e chi no.
Il buco nero è quando hai ventidue anni, ed un ragazzo che poi ti lascia, perché ti ha vista franare: e le sue mani sono troppo grandi per quel lavoro di fino che è rimettere insieme i tuoi pezzi piccoli piccoli…
Il buco nero è quando ne hai decisamente qualcuno in più, di anno: ma ti guardi comunque allo specchio, e ti dici che quella non è la tua faccia, non la riconosci proprio, e la cosa ti crea un panico terribile, e la detesti, e piangi tanto, fino a che è così gonfia che ti riconosci ancor meno. E scavi uno iato sempre più profondo, tra te e gli altri: perché “la vita è già difficile per tutti”, giusto cielo, e chi ne ha voglia di farsi rovinare le giornate da te?
In tanti c’han provato, a dargli un nome.
Ipocondria? Ansia? Disturbo post-traumatico da stress? Bipolarismo? Essere semplicemente fottuti nel cervello?
Io lo chiamo sempre “il buco nero”, la mia croce; ancora, dopo tanti anni.
Ma la cosa che più mi spaventa è che, oramai, col passare del tempo, come la mia rassegnazione ai suoi capricci, stenta a richiudersi un po’.”
Del posto al buio mi sono accorta per la prima volta quando ero bambina, e nel verde della campagna, dopo una giornata trascorsa a correre in giardino, montava dentro la paura della notte, del silenzio, di “non esserci”.
Facevo domande, cercavo risposte che non trovavo; o che forse, ancora nessuno reputava adeguate alla mia età.
Fissavo il soffitto sentendomi schiacciare.
Crescendo (soprattutto dopo la morte di mio padre) lo sforzo di relegare il posto al buio in una botola sotto ai miei piedi si è trasformato in una personalità istrionica e vorace, carismatica e brillante, protagonista e iperperformante, socievole e creativa.
Mi ritrovavo sempre a pensare che se avessi emanato luce a sufficienza da accecare chi mi stava vicino nessuno avrebbe notato che la zona cieca era talmente spaventosa da atterrire anche me, che ne ero consapevolmente l’inquilina.
Per uscire dalla prigione ho sperimentato tanti passpartout: emdr, terapia cognitivo-comportamentale, psicoterapia classica e sistemica, lexotan, zoloft, alprazolam in gocce e a rilascio prolungato, felison, paroxetina, sino agli antipsicotici e ai neurolettici di terza generazione.
Nel 2012 mi toccò addirittura il ricovero, in un padiglione che pareva un seminterrato, con un personale poco propenso a condividere parole gentili, ma solerte nel far scomparire i lacci delle mie Converse blu, considerate “oggetto potenzialmente lesivo.”
Quasi sempre, dopo qualche tempo, riuscivo a rimettermi in piedi: e l’illusione di stare meglio si traduceva sempre in un precoce abbandono della terapia farmacologica, che mi vergognavo di dover assumere.
(Perchè se oggi il ricorso alla psicoterapia è ampiamente sdoganato, è altrettanto vero che, nell’immaginario collettivo, la psichiatria rimane in compenso prepotentemente collegata al delirio, alla contenzione, ai pasticconi che ti “sballano” e che creano dipendenza, alla follia).
L’unico risultato a cui la mia incostanza conduceva era, però, quello di dilatare gli iati temporali in cui il buco nero se ne stava in disparte, rimanendo rinchiuso nel sottosuolo, con la carità temporanea di non invitarmi ad entrare. Anni in cui la sensazione di riuscire a mantenere il controllo consentiva alla mia personalità in luce di trionfare, rendendo desiderabile la mia compagnia, encomiabili le mie prestazioni al lavoro e scoppiettanti le mie battute.
Sino al successivo cedimento strutturale: sino a quando un qualsiasi stimolo esterno avrebbe spalancato nuovamente la voragine sotto ai miei piedi, deprivando, ricaduta dopo ricaduta, il mio corpo dello slancio che gli consentiva di scalare nuovamente il ventre della terra, per provare ad uscirne.
Un abitante del buco nero come me ingenera, in chi rimane fuori dall’orrido, sentimenti contrastanti. Dolore, compartecipazione, empatia e pietà vengono sostituiti a poco a poco da incomprensione, rabbia e frustrazione, da uno strisciante tono di accusa, che pone alla berlina la mancanza di volontà di quella larva che non si alza dal letto, che non è in grado di cucinarsi un pranzo decente, che non butta la spazzatura.
La vergognosa rinuncia nel provare “a fare appello alle proprie forze” appare agli interlocutori imperdonabile; perchè nella percezione di molti, dopotutto, “basta volerlo”, no?
“Guai a dire a chi ne soffre: «Sforzati». E invece lo si dice quasi sempre. Non può. Come non si dice a un malato di polmonite: «Dai, respira più forte e regolare, sforzati» o a un malato di cuore di darsi da fare per controllarne il buon funzionamento. Sì, la gravità dei disturbi psichiatrici è al livello delle malattie appena citate, ma non ne viene riconosciuto il peso e la specificità.
Se si ammalano i polmoni, se si ammala il cuore, perché non può ammalarsi un organo tanto più complesso come il cervello?”
La verità è che alle volte, sebbene si sia i primi a soffrire, altro non rimane che provare ad essere indulgenti con sé stessi, e con gli altri. Perchè il posto al buio è realmente un’insidia di fraintendimenti: un luogo talmente oscuro da atterrire i sensi di chi lo vive; da rendere fumosi ed annebbiati i confini tra psicosi e realtà. Consapevolmente, dunque, i suoi enigmi non possono essere decrittati e compresi da chi ha la fortuna di non averlo mai conosciuto; ed è bene che sia così.
Per chi ha una psiche di ferro, il posto al buio rimane un’incognita, un vizio della volontà, un segnacolo di debolezza: un hikikomori da te deliberatamente ricercato, quasi con compiacimento bieco, perchè “trovi scuse”, perchè “non ti impegni”; perchè ti “sottrai alle tue responsabilità.”
Il posto al buio è invece una malattia dell’anima, e della percezione: a forza di ricaderci, anche tu ti convinci che sia impossibile uscirne; che nessuna terapia sia significativamente in grado di aiutare; che non possa che essere il tuo unico habitat naturale designato; che forse, a questo punto, sia meglio risolversi a prendervi posto a vita, e ad arredarlo; che chi ti accusa abbia ragione, che tu sia una persona deplorevole, debole e viziata, perchè “non ce la fai”; perchè hai bisogno di “pillola blu, pillola gialla e pillola rosa” per riuscire a ritrovare la lucidità del pensiero; un atto di resa imperdonabile agli occhi di chi, diversamente da te, la forza di sopravvivere “ce l’ha.”
Forse, la sfida più difficile per abbandonare quel tranello è non cedere al suo doppio inganno.
No; abitare il posto al buio non è una scelta stilistica. Non è un segnale di inettitudine. Non è una sconfitta esistenziale.
Abitare il posto al buio è una malattia.
E quel trittico di pillole alla Matrix non è una condanna, una vergogna, un’onta. Ma è ciò che ti serve per provare a lottare; per riguadagnare il tuo diritto di vivere dissipando le ombre che ti tengono prigioniero; per provarci ancora, con le unghie e con i denti.
Abbi il coraggio di ricordarlo: e se la risalita lungo il suo cratere ti appare sempre più faticosa poniti, piuttosto, dei piccoli traguardi. Fai un passo alla volta. Sii indulgente. Affidati ai professionisti. Ricordati che sei importante. E chiedi aiuto.
©Pic Credits AFP Getty Images