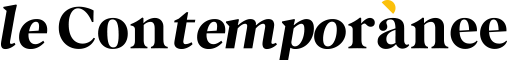C’è una battaglia silenziosa, ma profondamente politica, che si gioca negli Stati Uniti di oggi: quella per il controllo della memoria. Sotto l’amministrazione Trump — e ancora di più nella sua retorica attuale — è evidente un tentativo di “normalizzare” il passato, rimuovere le ombre, rimpacchettare la storia afroamericana dentro una narrazione patriottica, unitaria, rassicurante. Ma rassicurare chi?
La schiavitù non è un dettaglio da sfumare. È una ferita fondativa degli Stati Uniti, che ha generato disuguaglianze sistemiche ancora evidenti: nelle carceri, nei salari, nei tassi di mortalità materna. Eppure, proprio su questo punto si moltiplicano — a destra — i tentativi di censura o revisionismo: dalle leggi che impediscono di insegnare il razzismo strutturale nelle scuole, alle immagini rimosse dagli archivi militari perché mostrano troppa diversità.
Il problema non è solo Trump, ma il “Trumpismo” culturale: quell’idea che ricordare la schiavitù sia divisivo, che parlare di razzismo sia offensivo, che l’identità americana debba essere bianca, forte, pulita.
E allora sì, serve dirlo chiaramente: non è “unità” voler dimenticare. È privilegio. E il privilegio — soprattutto quando si fa politica — è il contrario della democrazia.
Per noi, che guardiamo alla realtà con occhi femministi, intersezionali, civici, questa non è solo una questione americana. È un avvertimento globale: ogni volta che una storia viene cancellata, una parte di noi viene messa a tacere. E noi non abbiamo intenzione di tacere.