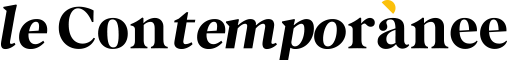È difficile destreggiarsi con saggezza, in un mondo di forze in aspro conflitto.
In un mondo che ha faticosamente decostruito l’iperperformativitá, per rivendicare il diritto al fallimento; ma che oggi, invece, sembra sempre più spesso fare dietrofront.
Che cosa ci è accaduto? Perché, se fino a poco tempo fa, accoglievamo con entusiasmo le lacrime, e la pelle acneica dei nostri idoli, che decidevano improvvisamente di ricordarci che mostrarsi come tutti gli altri potesse risultare terapeutico, ora che il dolore degli altri ci bombarda in maniera così costante, desidereremmo solo che lo nascondessero, per riuscire, forse, a dimenticarci meglio anche del nostro?
I mutamenti e le trasformazioni profonde che abbiamo attraversato nell’ultimo quinquennio, grazie ai nuovi strumenti che ci hanno consentito di leggere la realtà attraverso lenti differenti, hanno finito per porre sempre più in crisi le categorie interpretative tradizionali, suscitando, tuttavia, la frustrazione di chi ad esse si arroccava (anche per istituzionale mancanza di strumenti culturali): il disorientamento e, non di rado, persino l’odio.
Anche l’approdo a modalità di condivisione sempre più fruibili ed indiscriminate, che consentono quasi sempre di esprimersi senza filtri, e senza conseguenze, ci spingono oggi a chiederci quali siano i confini entro cui possiamo muoverci, per non essere colpiti troppo dolorosamente da chi riterrà di dover stigmatizzare i nostri pensieri.
Già. Perché noi, oggi, del nostro dolore, che cosa dovremmo mai farci?
Quando un amore finisce, siamo attraversati da sentimenti contrastanti. Una parte di noi, per intrinseca debolezza della natura umana, desidererebbe soltanto ricevere conforto, protezione, calore: un’altra, mostrare invece disperatamente che è ancora in sella, e che va tutto bene. Una terza, invece, è tentata solamente di rannicchiarsi nel suo piccolo spazio inviolabile, e di rimanere in silenzio, crogiolandosi nel dolore.
Un equilibrio irraggiungibile tra tutte e queste tre condizioni funamboliche sembrerebbe, apparentemente, ciò che le pagine di psicologia (sagacemente proposte dagli spietati algoritmi ad ogni cuore spezzato) tenderebbero a proporre, quale ricetta più sicura di benessere.
Ma una simile compenetrazione è veramente molto complessa, da realizzare. Specie quando entra in conflitto con molte altre forze vettoriali, che muovono i fili della nostra vita nel mondo.
Che cosa si aspettano, gli altri, da noi, in questo momento? E noi? Che cosa ci aspettiamo?
Fare advocacy del proprio diritto a soffrire sembra diventato sempre più rischioso. Condividere i tuoi pensieri, poiché senti di averne bisogno, susciterà la benevolenza di chi può offrirti una parola di conforto? O finirà, viceversa, per condurre soltanto gli amici di lui a definirti “una sottona” senza rimedio, e a condividere screenshot e sfottò?
Il nemico di ogni cuore spezzato, dall’amore o da ogni altro genere di piccolo attentato, è, del resto, l’inaridirsi dell’ empatia. La pornografia del dolore ci ha anestetizzati; le brutture della vita quotidiana ci hanno resi sordi, sulla scorta di un seppur legittimo istinto di sopravvivenza; la ricerca spasmodica di un sollievo ci ha resi incapaci di prenderci il nostro tempo per analizzare veramente il dolore, nostro ed altrui; per sviscerarlo, per sentirlo; e per avere la forza fisica e mentale di chiederci da dove nasca, perché nasca, e come poterlo davvero lenire.
Cosa fare, dunque, in un mondo che ci confonde con messaggi contrastanti? Dove l’intersezionalità ci ha insegnato a tener conto di noi stessi, e degli altri, ed i rapporti di forza a dominare, per non essere dominati?
Dove la narrazione combatte alacremente, ma spesso soccombe, a fronte del linguaggio crudele delle mancanze istituzionali, della povertà, della disperazione, della solitudine e dei problemi sociali di chi non vi può accedere?
Dove l’advocacy ci ricorda incessantemente il nostro diritto a commettere errori, ma finisce per condannarci duramente se per caso, poi, li facciamo per davvero?
La domanda più personale che mi sono posta, in questi giorni, il gigantesco corollario di tutte queste teorie sull’egoismo, è proprio, alla fine; questa qua: ma io, del mio dolore, del mio amore, adesso, che cosa ci devo fare?
Le risposte, comprensibilmente, latitano. Perché siamo confusi.
Questa società ci ha confusi, ha mischiato le carte, ci ha dato e ci ha tolto, ci ha elevato e ci ha abbrutito, ci ha aperto porte senza lasciarci le chiavi, ci ha mostrato la bellezza del mondo ma ci ha lasciato ad abitare i nostri spazi intimi di sofferenza, ci ha letto fiabe della buonanotte ma ha lasciato che la realtà del capitalismo continuasse il tuo eterno fluire distopico, ci ha riparato solamente per romperci meglio.
Siamo tutti in una centrifuga.
Ed uscirne restando in piedi, come chi ci circonda si aspetterebbe, forse, che facessimo, avendo la creanza di non disturbare, di non fare rumore, alle volte, risulta davvero impossibile.