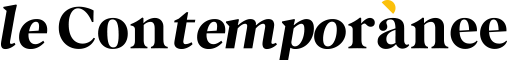Anni di battaglie per una comunicazione più rispettosa e consapevole rischiavano grosso, quando ad inizio ottobre 2025, il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia, insieme al collega Salvo Pogliese, aveva provato a far sparire dal Codice della strada il divieto di pubblicità sessiste, discriminatorie o violente.
Un emendamento, presentato nel contesto del DDL Concorrenza, che se approvato avrebbe riaperto la porta a quei manifesti che trasformano il corpo femminile in strumento di marketing, o che veicolano messaggi offensivi verso categorie sociali protette.
Il divieto, introdotto nel 2021 durante il governo Draghi, non era infatti nato per “limitare la libertà d’impresa”, come sostengono i promotori dell’abrogazione, ma per tutelare la dignità delle persone nello spazio pubblico.
La legge vieta la diffusione, su strade e veicoli, di messaggi pubblicitari che contengano contenuti sessisti, stereotipi di genere, o riferimenti violenti e discriminatori.
Una norma di civiltà, in linea con le raccomandazioni europee e con il codice di autodisciplina pubblicitaria, che negli ultimi anni ha contribuito a ridurre l’esposizione di immagini degradanti o offensive.
Secondo Malan, quel divieto rappresenterebbe invece una forma di censura: «Lo Stato non può decidere cosa sia offensivo», ha dichiarato in un’intervista, sostenendo che il divieto andasse a ledere la libertà di impresa.
Ma la libertà, in democrazia, non è mai assoluta: finisce dove comincia la dignità altrui. E in questo caso, la “libertà d’impresa” non può trasformarsi nel diritto di sfruttare stereotipi e discriminazioni per vendere un prodotto.
Le reazioni del mondo della comunicazione e delle associazioni femministe sono state immediate.
La pubblicitaria Annamaria Testa ha parlato di «un tentativo di riportare indietro l’orologio della civiltà di trent’anni», ricordando che la stessa industria si è dotata di regole etiche ben più severe.
«Oggi, nessuna grande azienda vuole essere associata a un messaggio sessista. Il danno reputazionale sarebbe enorme», ha aggiunto.
Dello stesso parere, anche le associazioni per i diritti delle donne, e le realtà attive sul fronte della parità di genere, tra cui le Contemporanee.
“Come MediaCivico, riteniamo gravissimo che si possa anche solo ipotizzare un ritorno a forme di comunicazione pubblica che umiliano ed oggettificano le donne, e che rappresenterebbero un dannoso passo indietro rispetto alle conquiste civili e culturali ottenute con fatica.” Avevamo scritto, in un comunicato stampa diffuso su social e web.
“Le Contemporanee operano, infatti, con uno sguardo critico ed inclusivo, contrario ad ogni forma di discriminazione. Siamo fermamente contrari*, pertanto, ad un qualsiasi uso dell’immagine e del linguaggio che sminuisca, oggettifichi, marginalizzi o svilisca le persone, per il loro genere o per altre caratteristiche che le definiscono, e che le determinano.”
Dietro la cancellazione del divieto, è stato talvolta intravisto un obiettivo politico più ampio: rileggittimare campagne “pro-vita” e antiabortiste, spesso censurate in base alla norma del 2021.
Togliere il filtro sui contenuti “discriminatori” avrebbe infatti permesso il ritorno di messaggi contro il diritto all’aborto o le famiglie omogenitoriali, oggi limitati proprio dalla definizione di “contenuti offensivi”.
Il tentativo è fallito — almeno per ora.
Con la fiducia posta dal Governo sul DDL Concorrenza, tutti gli emendamenti sono decaduti. Ma il segnale politico resta: dentro la maggioranza, c’è chi considera le norme contro la comunicazione sessista come un intralcio “ideologico”, non come una tutela democratica.
E proprio questo, forse, è il dato più preoccupante.