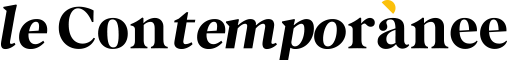Ho sempre pensato a noi della Gen Y come agli spiantati descritti con efficacia dal soliloquio di Tyler Durden nella celeberrima scena di Fight Club: “Siamo i figli di mezzo della storia; non abbiamo nè uno scopo nè un posto.” Perchè del resto, quella citazione iconica ed immortale sembrava adattarsi bene a chi, come me, aveva vissuto la propria infanzia a cavallo tra la plancia del Mondo disegnata con i gessetti, sull’asfalto rovente del Quartiere delle Sabbie, e l’avvento della playstation: tra i motivetti anni ‘90 della pubblicità, le schede ed i gettoni telefonici, la Lira ed il Millenium Bug; e poi l’Euro, il cellulare, il PC e l’Euroconvertitore, cadeau di Berlusconi alla sua seconda ondata.
Destreggiarsi tra due mondi, con i piedi saldamente ancorati alla morale manichea dei nostri genitori e lo sguardo rivolto alla Luna, con il tempo, si sarebbe confermata la nostra sfida più difficile. Per quanto mi riguarda, questo assunto è stato vero soprattutto per ciò che concerne la nostra dimensione più intima, e più naturale. Il sesso.
Ad adolescenza ormai inoltrata, mi era subito risultato chiaro che qualcosa, in me, non “funzionava proprio come avrebbe dovuto”. Assistevo sola, et pensosa, alle conversazioni tra amiche durante l’intervallo; tra compagne di ginnastica negli spogliatoi e tra conoscenze ondivaghe del sabato sera e constatavo, con dolorosa alienazione, che quell’allettante mondo di desiderio, di fantasie proibite e, talvolta, di sfacciati lamenti, a fronte di un’astinenza che si protraevaa da un bel po’, mi risultava completamente estraneo.
Sì. Perchè io, la voglia di fare sesso non ce la avevo quasi mai: quello scambio appiccicaticcio di fluidi con semi-sconosciuti mi pareva un errore procedurale; un’aberrazione che al mio corpo, con il quale intrattenevo un rapporto di fiducia così faticosamente conquistato, non potevo proprio infliggere.
Gli anni passavano: le compagne di liceo diventarono di Università; ma anche di faccia alla magniloquente immobilità del Campus di Via Festa del Perdono, il contenuto delle confidenze a sfondo sessuale non cambiava, così come non mutava il mio senso invariabile di alterità. Io non avevo un vibratore; io non mi masturbavo; non ne avevo voglia; se mi capitava di fissare uno sconosciuto, io non macinavo mai desideri rapaci, ma mi chiedevo piuttosto se, di notte, dormisse con i calzini; se il biondino del chiostro che studiava giurisprudenza, un leccese che pareva un Chris Hemsworth della prima ora, mi invitava nel suo appartamento dopo le lezioni, io rifiutavo, perchè sapevo già come sarebbe andata a finire.
Con il tempo, ovviamente, insieme alle mie constatazioni, avevano iniziato a farsi strada nel sentire comune anche le considerazioni estrinseche sulla faccenda tutta. E le amiche, scherzando, mi domandavano se fossi “frigida”, inibita da una morale ultracattolica; traumatizzata da un qualche evento spiacevole o, forse, tutte e tre.
Queste domande, talvolta, me le ponevo anche io, sebbene completamente a torto: perchè le risposte le conoscevo già. Avevo perso la verginità anni addietro, con un fidanzatino che mi aveva spezzato il cuore; l’amplesso era stato tutto sommato discreto, e dunque prova che, perlomeno, “frigida” non potessi essere, o non del tutto. Quanto alle supposte remore legate ad una morale castrante, il fatto non sussisteva: avevo ricevuto in forma coatta i più inflazionati sacramenti, era vero; ma dopo due annualità di Storia del Cristianesimo, mi ritrovavo più propensa a credere solamente in dei mortali.
La soluzione più logica mi apparve allora prendere il tono per le corna, ed esorcizzare il problema con le leggi del contrappasso: io avrei fatto sesso, perdiana, e lo avrei fatto come si conveniva.
Ebbi un paio di esperienze take away, come il costume a me coevo iniziava ad imporre con sempre maggior frequenza ai giovani moderni: i risultati furono a dir poco biasimevoli.
Provai disgusto, disagio quando non direttamente fastidio: una notte addirittura, pur di evadere da un inevitabile rapporto con un genovese dalle mani brune e grandi, evasi da un balcone (sito al secondo piano).
Le reazioni dei miei partner di una notte, sedotti ed abbandonati, non furono sempre ( e forse, non del tutto a torto) molto Zen.
Il repertorio più inflazionato proponeva sempre i soliti: “sei una figa di legno”; “pare di sfondare un muro di gomma”; “il tuo zio perverso ti ha stuprata da piccola?”; “non ti sai divertire”; “sei una suora travestita da zoccola”; “ma dalla un po’, dai retta a me, quando avrai 60 anni, dopotutto, nessuno te la chiederà più.”
Iniziai allora a credere che la soverchia freddezza che mi invadeva, ogni volta che, nella mia brillante vita di studentessa di vent’anni si profilava un rapporto sessuale con un partner magari anche stimolante, dovesse essere il frutto di un malfunzionamento biologico; di un complesso sistema di specchi e leve retrostante il mio apparato che, nel momento giusto, si ostinava sempre a fare tutte le cose sbagliatissime. Mi visitarono più ginecologi, riscontrando sempre lo stesso quadro: utero normovetroflesso, struttura regolare, genitari da nullipara; vagina positiva allo swab test per vaginismo in più quadranti; ipertono del pavimento pelvico. Che finalmente avessi trovato la spiegazione alla mia tara genetica, dunque? Che fosse il mio corpo, il traditore?
Il terapeuta che (da tanti anni) mi seguiva non appariva poi così convinto.
“E se quell’ipertono fosse conseguenza, anzichè causa?”- Si domandava fumando una pipa da clichè, trincerato nella mole statuaria d’un Giorgio Faletti più imponente – “E se è proprio per quell’assenza di desiderio, che lei, invece, mi si chiude?”
Mentre la mia onnipresente recherche Proustiana continuava ad essere ben lungi dal trovare risposte, avevo raggiunto l’età di ventisei anni: mi ero innamorata e, poichè con il mio fidanzato dell’epoca avevo normali rapporti sessuali, sulla sostanza del problema aveva finito per depositarsi lo spesso velo della polvere, e dell’oblio.
Ma l’elefante nella stanza, immanente e assai sgradito, continuava imperterrito ad esistere: quando la relazione con Marco finì, precipitai nuovamente nell’inerzia per anni, a cui si aggiunse il peso insopprimibile di altre domande senza risposta. Perché, se con lui, il sesso poteva risultare un’esperienza addirittura godibile, in sua assenza era ritornato a somigliare a una minacciosa lotta greco romana, marcata da una vicinanza fisica che mi atterriva? Perché, seppur essendo una donna in salute, (alle volte) brillante, e piena di vita, continuavo a preferire, all’idea di proseguire una serata di disquisizioni intelettuali a casa del mio avvenente interlocutore, quella di consumare un vasetto di Nutella, nella solitudine della mia?
Poteva essere davvero un problema di morale interiorizzata, del quale non mi rendevo conto neppure io? Mi ero interrogata anche su questo; ma mi ero risolta ad escluderlo. Non riscontravo nulla di esecrabile nel modus vivendi delle amiche che, nella piena consensualità tra parti, facevano sesso quando lo desideravano. Solo che, non andava bene per me.
Piuttosto, era il mio modo di vivere che mi appariva segnato da una maledizione incomprensibile, da una fobia che non sapevo neppure qualificare, se non con l’evitamento a cui sempre finiva per condurmi.
Gli anni passavano ancora: e mentre, alle mie spalle, le risatine e le congetture sulla qualità del legno che si celava dentro ai miei slip (massello o ebano? acero o palissandro?) si moltiplicavano, là fuori, qualcuno più di me si industriava per ritagliarsi il suo spazio nel mondo, e con idee assai più chiare.
La comunità LGBT + aveva, se possibile, intensificato ulteriormente i propri sforzi educativi e culturali, interessando sempre più giovani allo scavo dell’interiorità, e ad un’educazione sentimentale ed affettiva che evadesse gli stereotipi tradizionali della “brava bambina” e dei “boys don’t cry”. E fu così che, superati ormai i trent’anni, sentii parlare per la prima volta da una persona trans di “demisessualità”: un termine usato ex novo soltanto nel 2006, sul portale “Asexual Visibility and Education Network”, ed utilizzato poi nel 2008, nel “Réseau pour l’Education e la Visibilité de l’Asexualité” (quando avevo 17 anni, e da due abbondanti, oramai, mi chiedevo cosa ci fosse di sbagliato in me).
Scoprii che questa parola, “inserita nel più ampio spettro dell’asessualità”, indicava “una forma espressiva e sessuale capace di esprimere anche un desiderio intenso e profondo, purché sempre attivato da un preliminare forte legame affettivo, in assenza del quale, l’attrazione sessuale non è in grado di scaturire.”
Più che l’emozione, potè la sorpresa: non fu tanto la scoperta di non costituire un’eccezione patologica ad ubriacarmi di euforia, e di sollievo; ma la meraviglia di non essere sola. Dunque, ce n’erano “altri”: e tutti quegli anni di sfottii, illazioni crudeli ed allusioni alla perversione insita nei miei rifiuti non avevano ragion d’essere; perchè io, finalmente, ero stata rappresentata. Perchè io, finalmente, esistevo. Non vi era nulla di sbagliato, in me: semplicemente, il mio modo di vivere la sessualità non poteva prescindere dal provare un sentimento che, per i più, poteva anche rappresentare un bene accessorio; ma che, per me, era condizione irrinunciabile di benessere.
Oggi più che mai, a fronte di un panorama politico troppo spesso impermeabile ai bisogni della comunità LGBT + (e “degli altri da sé”, in generale), non dovrà farci sorridere quel linguaggio inclusivo, così ostinatamente (ri) cercato. Non quella volontà di abilitazione; di vedere e fare vedere; di lottare perché tematiche e persone entrino nel dibattito pubblico; ricevano un nome ed un’identità.
Perché la rappresentazione (oltre ad educare l’opinione pubblica,e gli altri) educa noi stessi: diviene un tassello irrinunciabile, nel percorso di (una troppo spesso) dolorosa accettazione di sé.
Oggi, che ho 31 anni, la spilla che rappresenta la bandiera demisessuale l’ho trovata ad un stand benefico dell’Arci-gay, e l’ho graffittata a quella borsa che mi porto sempre appresso. Perché se è vero che da quella zona grigia non posso uscire (perché io sono, quella zona grigia), oggi la ho abitata, e la ho fatta mia.
Perché se è vero che sono stata una ragazzina spaventata, convinta di essere “fatta di legno”, oggi, non più.
Oggi, so che (fatta eccezione per la mia unica, irripetibile soggettività) sono fatta di tutto quello, esattamente di tutto quello, di cui siete fatti anche voi.
Ed io – la libertà di essere, e di essere vista – la voglio indossare orgogliosa: anche per chi sta ancora lottando, ed arriverà – un giorno, ci arriverà – in quel posto di cui ancora non conosce il nome, ma che, nei suoi sogni “sa com’è.”