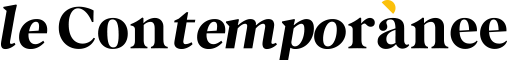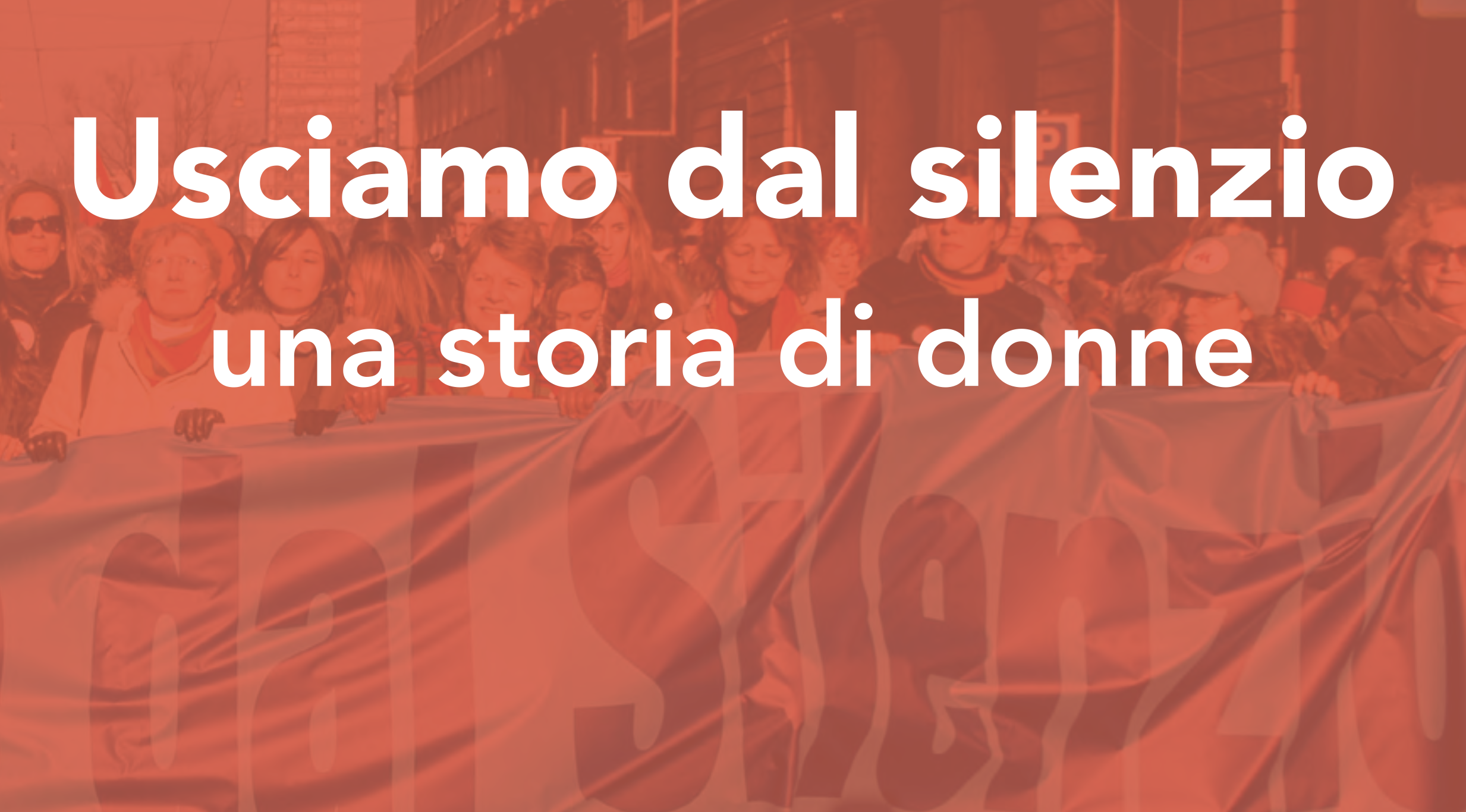È un diritto o non lo è, una precondizione della libertà delle donne o il lato oscuro della maternità?
Nato il governo Meloni ed affidato ad Eugenia Roccella il ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (il nuovo vocabolario della destra indica una forte sfida di egemonia culturale, rendiamocene conto), il dibattito sull’aborto che si era già riacceso nell’estate si è fatto vieppiù aspro e, nuovamente, tra le donne, nei movimenti, nei femminismi, si vive uno stato di preallerta rispetto alle sorti della legge 194, legge bistrattatissima che continua da decenni a sopportare attacchi politici aperti e tentativi di svuotamento dall’interno.
Sembra ed è un film già visto: sotto il titolo ‘tutela della vita nascente’ si prevedono, come accade in Piemonte, soldi e sostegno ai movimenti pro Life che entrano nei consultori ad interferire nella relazione tra donna e personale sanitario e non è la prima volta. Dall’Umbria arriva la denuncia di donne che vogliono interrompere la gravidanza e sono costrette – in Ungheria ciò è legge dello stato – ad ascoltare il battito del feto, in molte regioni la possibilità di abortire è di fatto pregiudicata da tassi altissimi di obiezione di coscienza e viene ostacolato o reso più difficoltoso l’utilizzo della RU486. Una legge si può sputare e indebolire in tanti modi, non necessariamente con una battaglia in campo aperto.
Su questa scena è caduta la nomina di Roccella e la grande eco del suo dire che l’aborto non è un diritto, che lo ha imparato dal femminismo che così argomentava negli anni ‘70, che si tratta invece ‘del lato oscuro della maternità’. Molte le repliche, sia sul punto del diritto – Marilisa D’Amico ricorda opportunamente che la 194 è una legge a contenuto costituzionalmente garantito, espressione di diritti costituzionali e dunque non abrogabile per via ordinaria – sia sul punto che riguarda il femminismo. Una per tutte, Ida Dominijanni, ha ben spiegato che per il femminismo della differenza sostenere che l’aborto non è un dritto, significa dire che è di più, ovvero una libertà in capo alle donne, e che a ciò rinviava il dibattito di allora tra chi pensava necessaria una legge che lo regolamentasse e chi si batteva per la depenalizzazione.
Coincidenza vuole che da poco tempo (se ne è discusso giovedì scorso alla Casa delle donne di Milano in una prima presentazione pubblica molto partecipata) sia uscito in ebook (scaricabile gratuitamente qui: https://www.ledizioni.it/prodotto/usciamo-dal-silenzio/) “Usciamo dal silenzio: una storia di donne”, la ricerca condotta sull’archivio del movimento da Maria Grazia Gambardella, sociologa dell’università Bicocca, accompagnata da uno sguardo dall’oggi di quattro tra le fondatrici che, in dialogo tra loro, firmano la postfazione.

A Usciamo dal silenzio si ascrive infatti la più grande mobilitazione di piazza in tema di interruzione di gravidanza e di legge 194 registrata in questo paese: correva l’anno 2005 quando il governo di centrodestra minacciava una revisione della legge con annessa commissione d’inchiesta, ricompariva l’ipotesi di figure di dissuasori nei consultori, le gerarchie ecclesiastiche scatenavano un’offensiva, peraltro mai finita, sul tema. Innescata da una mail preoccupata inviata da chi scrive e rimbalzata tra tante, prese forma la prima, affollata assemblea, segno di quei periodici e forti risvegli di mobilitazione che il movimento delle donne vive e rivive, come diceva Lidia Menapace. Il resto, ben ricostruito nell’ebook e con le immagini di Isabella Balena, è cronaca di allora e storia del movimento delle donne italiane: duecentomila in piazza in un sabato di sole il 14 gennaio 2006. Il più bel titolo, il più azzeccato su quella manifestazione lo fece il settimanale Diario: ‘Le libere donne di Milano’.
Era giusto quel titolo ed ha tuttora senso ampio quell’aggettivo coniugato alla battaglia per l’aborto, qui, negli Stati Uniti, in Polonia, in quel gran pezzo di mondo in cui viene negato ed ostacolato il diritto delle donne ad avere un’interruzione di gravidanza sicura e legale. Non è stata, non è oggi una battaglia difensiva quella cui siamo costantemente richiamate e che fece nascere Usciamo dal silenzio, che poi continuò per dieci anni la sua azione, prima come movimento, poi come associazione lavorando su temi tuttora di grande rilevo, dalla violenza maschile contro le donne alla rappresentanza politica, questione caldissima oggi con il premierato Meloni.
Il nesso con la libertà femminile ci era chiaro allora (e lo era anche molto anni primi quando scendemmo in piazza a Roma con lo slogan ‘La prima parola e l’ultima’) ed è chiaro adesso. E, con in mano l’ebook che racconta questa storia di movimento delle donne e la commenta con gli occhi di oggi, paiono ancora utili la parole usate allora quando, convocando quella manifestazione, scrivevamo che la vicenda dell’aborto parla della reazione tra i sessi e della responsabilità maschile, che “chiunque si arroghi il diritto di imporre una gravidanza non desiderata in termini di divieti, aiuti, controlli, considera le donne una categoria sociale a potestà limitata” e che difendere la 194 significa “guardare più lontano, alla libertà di donne e uomini di decidere di sé, delle proprie vite, di quelle a venire”.
Anni dopo, nel 2013, Uds, insieme alla Libera università delle donne e ai Consultori Laici, organizzò un convegno nazionale con giuriste, ginecologhe, formatrici e attiviste e scrisse un manifesto sul quale indisse una fortunata raccolta di firme: c’eravamo chieste cosa vuole una donna quando decide di interrompere una gravidanza perché ci sembrava questa la domanda chiave e il punto di vista dal quale affrontare la questione. C’eravamo risposte – l’ebook ne racconta diffusamente – che la risposta stava in tre concetti: rispetto della propria scelta, una corretta accoglienza e la sicurezza per la propria salute. Concetti densi, esaustivi, purtroppo ancora lontani dall’essere diffusa esperienza per chi decide di non proseguire una gravidanza nel nostro paese. Concetti da rilanciare, nel dibattito pubblico e nei luoghi in cui la 194 si pratica, respingendo la strisciante colpevolizzazione delle donne e avendo ben chiara che la posta in gioco è culturale quanto, per le vite di tante, concreta.