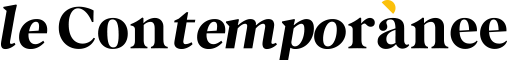Ogni settimana Zara lancia nuovi trend e nuovi prodotti, così come fanno H&M, Primark e tutti gli altri marchi che si inseriscono nella categoria della fast fashion. Con questo termine, che letteralmente significa “moda veloce” si fa riferimento a quel modello che, a partire dagli anni 2000, ha rivoluzionato l’attività manifatturiera, rendendola la seconda industria più inquinante del mondo.
La caratteristica della fast fashion è quella di offrire quotidianamente nuovi prodotti e nuovi stili (alcuni marchi producono fino a 50 nuove collezioni l’anno) a prezzi molto ridotti, ma anche di bassissima qualità. Ciò comporta una sovrapproduzione nel tessile e un consumismo sfrenato, che spinge gli acquirenti a comprare, usare, gettare, ricomprare e che ha come conseguenza la produzione di rifiuti, il consumo di risorse e la produzione di emissioni. Da un report pubblicato dal Parlamento Europeo, nel 2015 l’industria tessile ha utilizzato 79 miliardi di metri cubi d’acqua e nel 2017 è stata responsabile del 20% dell’inquinamento globale e del 10% delle emissioni globali di carbonio.
Inoltre, il prezzo molto basso dei prodotti ha un costo molto alto per chi li produce. Infatti, la fast fashion è anche responsabile di un gravissimo sfruttamento sociale: la filiera tessile che sta alle spalle di questi marchi si serve di industrie tessili dislocate soprattutto nei paesi più poveri del mondo -generando il c.d. dumping sociale esalariale-, paesi nei quali non vengono garantiti i diritti primari di lavoratrici e lavoratori (basti pensare che dei 75 milioni addetti nell’industria della moda, 60 milioni lavorano in Asia). Le grosse aziende, quindi, non hanno grossi costi di lavoro, ma hanno importanti profitti. Questo comporta che la manodopera soffra di condizioni igieniche e di sicurezza drammatiche, venga retribuita con uno stipendio insufficiente a vivere in modo dignitoso e abbia tempi di lavoro nettamente superiori a quelli che garantiscono un benessere lavorativo. Inoltre, nei paesi più poveri e in quelli in via di sviluppo, le leggi impediscono un qualsiasi potere sindacale e non garantiscono il diritto di associazione. A ciò si deve aggiungere il fattore di genere: l’85% delle persone che vengono sfruttate nella produzione tessile sono donne, molte volte vittime oltre che di sfruttamento lavorativo, anche di abusi e ricatti sessuali.
Il 24 aprile 2023 è ricorso il decimo anniversario dalla tragedia del Rana Plaza, tragedia che ha ferito più di 2.000 persone e che ne ha uccise almeno 1.138. Si tratta della più grave catastrofe mai avvenuta nell’industria tessile.
Il Rana Plaza era un edificio a Dacca, in Bangladesh, il quale conteneva una banca, alcuni negozi e alcune fabbriche d’abbigliamento che occupavano circa 5.000 persone e che realizzavano vestiti per marchi come H&M, Benetton, Camaïeu, Inditex (Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius), Mango, Primark, NKD. Il 23 aprile 2013, il giorno prima della catastrofe, erano state segnalate importanti crepe strutturali nell’edificio e, infatti, la banca e i negozi dei primi piani vennero immediatamente chiusi. Lo stesso non avvenne per le cinque fabbriche di vestiti: qui le operaie e gli operai tessili furono costretti a recarsi al lavoro sotto il ricatto di perdere un mese di stipendio, pur sapendo che la costruzione non era in sicurezza. Il disperato bisogno di una retribuzione, la mancanza di libertà di associazione e l’ambiente violento hanno causato la morte e le lesioni di più di 3.000 persone.
Questo massacro sul lavoro venne documentato e denunciato a livello mediatico e generò grande sgomento a livello globale, anche perché si stima che i brand di fast fashion fossero in parte coinvolti circa le condizioni in cui lavoratrici e lavoratori erano costretti a produrre. Vennero quindi promosse campagne contro lo sfruttamento delle operaie e degli operai nel mondo della moda e ONG e sindacati cominciarono a mobilitarsi per lottare a favore dei diritti della manodopera del settore.
Il dramma del Rana Plaza ha dato vita a Fashion Revolution, il più grande movimento di attivismo, ricerca e advocacy nel mondo della moda, che professa una coscienza sostenibile. La vision delle due fondatrici, Carry Somers e Orsola de Castro, è che l’industria tessile debba essere in grado di preservare e salvaguardare l’ambiente e che debba dare più valore alle persone che lavorano dentro l’industria. Tra gli obiettivi primari e più importanti c’è quello di rendere trasparente l’intera filiera che sta dietro ad un capo di abbigliamento. Infatti, se non si conosce il luogo dove è stato coltivato il cotone, chi e dove ha cucito il prodotto è impossibile assicurarsi che i diritti umani siano stati rispettati, che l’ambiente di lavoro sia sicuro e protetto. Senza la trasparenza è impossibile raggiungere l’obiettivo di un’industria sostenibile, responsabile ed equa.
Il 24 aprile 2022, in occasione del nono anniversario dalla tragedia di Rana Plaza, il Segretario Generale di IndustriALL Atle Høie ha evidenziato la capacità dei sindacati ad aver trasformato quella disgrazia in un accordo storico che ha reso le fabbriche tessili in Bangladesh luoghi più sicuri. Infatti, all’indomani della tragedia, le due organizzazioni sindacali internazionali -IndustriALL e UNI Global Union– insieme ad otto sindacati del Bangladesh hanno convinto 40 brands e rivenditori ad assumersi le proprie responsabilità, stipulando l’Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. La firma di tale accordo ha permesso che, a nove anni di distanza, siano state ispezionate e messe al sicuro 1.600 fabbriche e 2 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori. Tale accordo ha avuto effetti significativi perché ha riconosciuto autorità ai sindacati, i quali possono svolgere ispezioni in modo indipendente, possono formare la manodopera e hanno il potere di reclamo. Per mantenere i risultati ottenuti, nel 2018 il Bangladesh Accord è stato rinnovato con la sottoscrizione del Transition Accord, il quale è stato firmato da ulteriori centosessanta parti datoriali. Nel 2021 le controparti hanno dato il via ad una nuova fase di trattative che ha dato origine all’International Accord for Health and Safety in the Texile & Garment Industry il cui obiettivo finale è quello di garantire industrie tessili sicure per chi vi lavora, continuando il lavoro cominciato in Bangladesh, ma anche promuovendo programmi di sicurezza sul lavoro in altri paesi. Nel frattempo, nel 2022 è stato firmato il Pakistan Accord su ispirazione di quello siglato in Bangladesh. L’accordo, vincolante per i brand firmatari, è stato sottoscritto dopo l’ennesima tragedia in un’industria tessile: nel 2012, a Karachi, centinaia di operaie e operai tessili hanno visto la morte a causa di un incendio di vaste dimensioni. Nell’accordo sono coinvolti 187 marchi, di cui la metà si rifornisce da filiere in Pakistan.
I sindacati, oggi, devono riuscire a coinvolgere altri brand, potenziando il dialogo sociale. A livello globale le associazioni delle lavoratrici e dei lavoratori stanno lottando per un nuovo modello di supply chain, un modello che sia vincolato da regole che rendano i marchi responsabili del loro impatto sulla manodopera. In generale, è necessario che le operaie e gli operai tessili siano messi nella condizione di avere una protezione sociale, con cui si intende misure di tutela (come, per esempio, tutele per chi ha perso il lavoro, indennità dil licenziamento, di malattia e sicurezza sociale) che fanno parte dei diritti fondamentale di lavoratrici e lavoratori e che sono alla base di un luogo di lavoro sicuro, sano ed equo.
Gli ingredienti fondamentali perché si possa parlare di moda sostenibile sono quindi la sicurezza, la libertà sindacale e l’equità. La prima caratteristica di una lavoratrice o un lavoratore libero è l’avere un salario dignitoso, così da non poter essere ricattabile: per questo motivo Fashion Revolution, insieme a diversi sostenitori (tra cui World Fair Trade Organization Europe e Clean Clothes Campaign) sta promuovendo la campagna Good Clothes, Fair Pay con la quale si richiede alla Commissione europea l’introduzione di una legislazione che imponga ai marchi e ai rivenditori del settore della moda di garantire alle operaie e agli operai tessili un salario di sussistenza, ossia una retribuzione in grado di assicurare un tenore di vita dignitoso. L’obiettivo -raggiungibile solo attraverso la raccolta di 1 milioni di firme di cittadine e cittadini europei – è anche quello di far sì che i brand della fast fashion si impegnino a mettere in atto, ad implementare, a monitorare e a divulgare un piano per colmare il divario tra i salari effettivi e i salari di sussistenza.