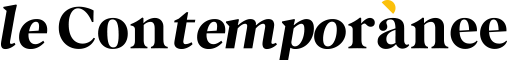Ancora una volta, Le Contemporanee diviene uno spazio di ascolto e di raccolta per le riflessioni di neo-madri che, con difficoltà ed impegno, tentano ogni giorno la conciliazione tra la propria vita di professioniste ed un nuovo e – complesso – ruolo.
Punti di vista che impongono con urgenza la necessità di una lucida e disincantata riflessione sul presente demografico in Italia, e sulle iniziative necessarie a lenire e supportare le solitudini e le difficoltà talvolta connesse alla filiazione.
Questa volta, a raccontarsi per noi è la giornalista ed esperta di comunicazione Barbara Polidori.
***
Ho sempre voluto un figlio, ma non l’ho mai detto apertamente perché soffrivo all’idea di non riuscire a conciliare i miei desideri con i ritmi sostenuti. Ora che ho avuto un bambino, a 36 anni non celebro la mia gravidanza come conquista femminile, ma convivo con un’amarezza post partum che mi ha segnata. In questo periodo di “apnea gestazionale” durato 9 mesi, avrei voluto una narrazione sulla maternità fuori dal coro che non c’è stata. Per me come per tante altre donne. Al contrario, ho convissuto le settimane della gravidanza in compagnia di luoghi comuni, stereotipi e banalizzazioni che spesso hanno innestato dentro di me un senso di solitudine per certi versi incomunicabile: una teca di vetro dove a tutti è concesso sbirciare, mentre tu rimani in una tua dimensione personale, separata. Ho così guadagnato in questo lasso di tempo uno scisma tra il mio mondo interiore, pieno di gratitudine per il figlio che cresceva dentro di me, e quello esteriore infastidito dal giudizio non voluto delle persone che mi circondavano.
Quella speranza silente di diventare madre si è alternata a momenti di profondo sconforto difficile da raccontare per chi non l’ha vissuto. Per anni ho pensato che questo senso di emarginazione fosse una pagina vissuta solo da alcune donne. Mi trovo ora, invece, a vederla come una vera e propria piaga sociale nel nostro Paese: in un modo o nell’altro proviamo tutte un senso di disagio mentre siamo incinte, ma con intensità diverse. Ti senti appesantita da uno stato fisiologico e transitorio di cui non è difficile accettarne tutti i crismi, ma non sai con chi parlarne dal momento che la maternità è un’esperienza del tutto soggettiva, temendo poi che ti venga affibbiata l’etichetta della “problematica” o dell’esaurita. O al massimo, come nel mio caso, sentirti rispondere “sono gli ormoni”, appiattendo in questo modo uno stato emotivo che mi ha pervasa dentro come un martello pneumatico. Se hai fondamenta psicologiche flebili, in quella marea di spaesamento e solitudine puoi sprofondarci, finire in depressione e ammalarti come ci è stato raccontato da tanti personaggi pubblici. Se invece riesci a difenderti, come nel mio caso, ne esci profondamente cambiata: ferita.
Nessuna riflessione che condividerò da qui in avanti metterà però in discussione quanto ho scelto per me stessa o il mio desiderio di essere madre. Perché anche se c’è chi vi vorrà far credere che una gravidanza può capitare, il che è del tutto vero, il modo in cui si decide di vivere la gestazione invece è frutto di una scelta completamente personale: ci si rende a disposizione, consapevolmente o no, di un’evoluzione da crisalide uterina a tutrice di futuri cittadini e cittadine, diventiamo responsabili di un’esistenza che un giorno avrà impatto sociale con le sue azioni. Uno spiccare il volo verso l’ignoto durante il quale ogni donna avrebbe bisogno di supporto, comprensione, discrezione e sensibilità. A tarpare le ali arrivano invece opinioni perlopiù nette e scoraggianti, soprattutto dalle generazioni che ci hanno precedute: il parto diviene un’esperienza traumatica, ma bellissima, crescere un bambino è raccontato come difficilissimo e sfiancante.
Non sono ancora mamma, ma so che il vero “sacrificio” che sono chiamata a intraprendere probabilmente sarà insegnare a relazionarsi con un mondo spesso sterile. Dando vita a un essere umano inauguriamo la creazione di un ecosistema genitoriale che si avvale di decisioni spesso difficili, ma che contribuiscono tutte a costruire una nuova galassia di valori, relazioni, equilibri che in questa società sono messi in discussione da un sistema sordo e privo di empatia. Ho perso il conto delle volte in cui, mentre mi recavo a svolgere le analisi per la gravidanza in ospedale, le persone in fila polemizzassero sul mio accesso prioritario, tanto per fare un esempio. Che tipo di mondo è quello dove un diritto viene percepito come un privilegio? Come possiamo sentirci incoraggiate da una società dove una donna incinta è vista come un’approfittatrice e non come una persona che necessita cure?
Viviamo in una realtà dove non ci sono armonia e ascolto sulla creazione, ma solo pretesa di dominare anche quello spazio di vita che in Italia è sempre più esiguo: se per la prima ministra Meloni il Pil italiano è in crescita, l’inverno demografico raggela ogni speranza sulla natalità nazionale, con le madri più anziane d’Europa. Eppure, se ascoltassimo le ultime proiezioni Istat, sapremmo che a questi ritmi l’ultimo italiano potrebbe vedere la luce nel 2225. Tra 200 anni circa, secondo una visione distopica, non avremmo più nascite.
Cosa si può fare allora in questo intervallo di tempo per impedire l’estinzione degli italiani? Mi piacerebbe che a rispondere non fossero Elon Musk, sbarcato nello stivaletto con il senso di onnipotenza del Dr. Manhattan di Watchmen, né tantomeno un Gasparri nelle vesti di una Maria Antonietta liberale che elargisce danari alle neo-mamme per impedire che abortiscano (“Se le donne in Italia non fanno più figli, doniamo loro 1.000 euro”). Mi aspetto che le risposte arrivino da quelle che Save the children ha denominato “Le equilibriste”: le donne che ogni giorno tentano faticosamente di orientarsi tra personale e professionale. Avrei voluto conoscere la storia di chi una gravidanza l’ha vissuta sulla sua pelle senza che fosse un trofeo, chi ha subito violenza ostetrica (che in Italia al 2022 ha coinvolto il 22% delle partorienti, me compresa), sentire la voce di chi ha vissuto un lutto prenatale e non ha trovato una rete di ascolto. Avrei voluto sapere da una madre single di quali sostegni economici si è avvalsa, considerando che solo lo screening prenatale ha un costo di circa 500 euro nel Lazio, figuriamoci tutto il resto. Oppure, sapere perché il Bonus latte artificiale, introdotto con la Legge di Bilancio 2020, sia previsto solo per donne con patologie gravi: in Italia, secondo un’indagine dell’Iss del 2022, l’allattamento al seno nei primi 2-3 mesi di vita coinvolge il 46% di donne, scendendo al 30% nei 4-5 mesi.
Lo ha evidenziato da Riccardo Davanzo, neonatologo e presidente del Tavolo tecnico Operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno (Tas), durante la IV Conferenza nazionale sull’allattamento al Ministero della salute a Roma. Come è sostenuta finanziariamente la nutrizione dei neo-cittadini italiani in questo Paese, quando non ce la facciamo da sole? Che dire, poi, del totale caos in cui si ritrova una neo-mamma quando deve allattare, considerando le informazioni frammentarie che ogni ostetrica fornisce sul metodo più corretto?
È interessante constatare come tante donne di una certa età sentano il bisogno di raccontarti la loro esperienza di parto ma nessuna invece si ricordi del mancato consenso all’episiotomia, della manovra Kristeller e del fatto che l’Oms le riconosca come pratiche rischiose. Se il parto è un mistero a cui si accompagna il semplicismo del “lo abbiamo fatto tutte”, dall’alto della presunzione di chi viene a dirti come vivere la tua gravidanza nessuna mi ha mai informata invece del “microchimerismo” e di quanto possa essere utile per la ricerca delle cellule staminali e degli effetti su chi, come me, ha una malattia autoimmune. Ho sopportato l’ottusità di chi giudica il secondo cognome come una cosa “non tradizionale”, ma nessuna mamma e donna mi ha mai giustificato perché per concedere il nostro cognome a una persona che portiamo dentro per mesi dobbiamo fare un’istanza alla Prefettura, pagando.
La vulgata comune addita il calo della natalità alla mancanza o inefficienza delle politiche di welfare, ma prima di arrivare a ragionamenti in termini di risorse, mi sono chiesta soprattutto il perché non siano percepite come priorità in Italia. Fuori dalla propaganda elettorale, dai cortei e dalle polemichette da Bar dello Sport, l’interventismo sul tema è stagnante. E no, l’emancipazione femminile e il rovesciamento dei ruoli uomo-donna non hanno portato a un calo delle nascite: c’è una mancanza di elasticità mentale anche nelle più piccole cose, nel quotidiano o nello scambio tra le persone. In questi nove mesi sono arrivata a credere che le cause di questa solitudine gestazionale derivino anche da quelle donne, prima gestanti, poi madri, prigioniere di un sistema di valori che i nostri genitori, amici, parenti e conoscenti tramandano da anni come in una catena di montaggio malata.
Siamo talmente tanto concentrat* nel puntare il dito contro il politico di turno, l’influencer controversa o la visione malsana diramata da reality e talk show, che abbiamo finito per dimenticare che nelle nostre case, nelle nostre cerchie di amici e persino dentro di noi c’è un gigantesco elefante nella stanza che non vogliamo affrontare. Che attende di essere messo in discussione e che invece addossiamo agli altri per paura di ritrovarci da sol* con le nostre più intime paure e fragilità.
C’è un tipo di cultura patriarcale di cui non si parla quasi mai. È quella che perpetrano le donne stesse. Le “sorelle” di lotta che condividono frasi motivazionali a suon di post sui social, facendosi immortalare a sit-in, centri sociali e cortei femministi e poi, nella vita di tutti i giorni, attivano comportamenti disfunzionali, emarginanti ed emotivamente immaturi. Quelle che “il corpo è mio e decido io” ma poi scrollano la home di Instagram per scandagliare la nuova ragazza del loro ex e colpevolizzarle la prima smagliatura. Quelle che supportano “il sesso libero e consenziente”, ma poi vanno in dipendenze affettive e non sanno autodeterminarsi al di fuori di un uomo. Quelle che se non hanno mai avuto una relazione affettiva si sentono menomate come donne. Quelle che vorrebbero una donna forte, indipendente e carismatica, ma quando ne incontrano una tentano di demolirla perché non supportano il peso della loro insicurezza, anche quella frutto di dinamiche patriarcali. Quelle che vorrebbero una società inclusiva, ma non sono nemmeno in grado di accettare se stesse e le loro fragilità. Quelle che non perdono occasione per denigrare gli uomini ritenendoli “tutti uguali”, per poi cercare in ogni modo di compiacere le loro attenzioni per sentirsi “desiderabili”.
Quelle che in un momento come questo, con 120 donne uccise solo nel 2023 e 25 da inizio 2024, anziché rafforzare la solidarietà femminile, si scagliano contro altre donne in difficoltà e le lasciano da sole. Quelle che pensano che avere dei figli colmi automaticamente la loro funzione sociale come donna, facendole credere di essere invincibili, avallando lo stereotipo banalissimo della “madre coraggio”, che ci ha francamente rotto le ovaie. Ci sono donne che non vogliono e non possono avere figli, ma avranno comunque bisogno di essere protette. Quelle che, all’interno di associazioni, sul posto di lavoro, nel gruppo di amici o durante il volontariato, fanno a gara a chi può avere le luci della ribalta, a costo di danneggiare altre di loro.
Durante la puntata di Domenica In di novembre 2023, l’ex magistrata della Lega, Simonetta Matone, parlando del femminicidio di Giulia Cecchettin ha semplificato l’episodio a suon di “Io non ho mai incontrato soggetti gravemente maltrattati e gravemente disturbati che avessero delle mamme normali”. La ministra delle Pari opportunità Roccella ha aggiunto, a chiosa, che le “madri devono educare i figli maschi al rispetto”. Le madri, non i padri, non entrambi i genitori. I padri al massimo diventano giudici della gara di rutto libero. Le donne non vanno colpevolizzate, ma di certo non vanno nemmeno giustificate quando supportano atteggiamenti incoerenti o peccano di ingenuità. Sono parte di un problema in cui si chiede anche a loro di agire responsabilmente. Una società inclusiva si costruisce con uno sforzo condiviso, chiedendo agli uomini di abbandonare le loro sovrastrutture socioculturali ma anche, e soprattutto, con il senso civico di essere femministe nella vita di tutti i giorni, con la maturità di fare rete tra donne, anche quelle che non ci piacciono, anche quelle che ci rubano “i riflettori”. L’obiettivo è comune.
E quest’obiettivo va abbracciato anche e soprattutto nella genitorialità che non è mai a due, ma è un processo armonico e olistico. È una coperta che avvolge anche chi abbiamo intorno. Avere dei figli vuol dire tracciare sentieri decisionali che impattano inequivocabilmente nella vita di tutti noi: chi portiamo in grembo un giorno sarà cittadin* del mondo e il modo in cui lo accompagniamo, dalla gestazione fino alla sua venuta reale, è la carta d’imbarco per un viaggio dove l’unico panorama a cui dovrebbe assistere è quello della comprensione. Nessuno può colpevolizzarvi mentre realizzate il faticoso processo di costruzione della vostra identità materna. A parte voi stesse, ed è per questo che in un momento tanto delicato, in cui ci si sente spesso sballonzolate tra l’ago dell’inadeguatezza femminile e quello della glorificazione della maternità, ho deciso di condividere un punto di vista diverso su come avrei voluto vivere la mia gravidanza. Non l’unico, ma uno che spero possa aprire una breccia laddove c’è immobilismo dialettico su un tema che è percepito come priorità nell’agenda politica solo di facciata. All’atto pratico le donne in Italia sono completamente sole in ogni istante, soprattutto quando hanno bisogno di aiuto. Occasionalmente ci ricordiamo delle difficoltà vissute se ce lo viene a spiegare una blogger con milioni di followers, se avviene un femminicidio o se una neo-mamma abbandona il figlio in fasce nel reparto maternità. Dove sono, invece gli aiuti che precedono il dramma? Chi dice che debbano arrivare per forza dallo Stato e non, invece, iniziare dalle famiglie, dalle amiche, dal compagno/a o persino dai datori di lavoro? Prima della governance, prima delle istituzioni, dei consultori e delle associazioni l’empatia dovrebbe arrivare da chi ci è vicino. Da chi non perde occasione per condividere reel e stories sulle pari opportunità, sull’autodeterminazione, sull’etica della famiglia queer della Murgia ma poi non ha nemmeno la decenza di mandarti un messaggio chiedendoti “Come stai?”. È quello il vuoto a cui sono condannate tante donne che scelgono di portare avanti una gravidanza, non c’è mi piace che regga a questa forma di ipocrisia.
C’è bisogno di meno proclami social e specchietti per le allodole delle multinazionali per investire invece su più attività didattiche e programmi formativi che educhino le persone all’educazione emotiva, all’utilizzo responsabile e consapevole della comunicazione, in primis via social, come già ci provò Anna Masera su La Stampa nel 2019. I social, intesi come stanze dematerializzate, hanno conseguenze concrete: sono fucine dannose perché rilanciano modelli femminili malati, che raccontano la gravidanza come il momento più bello nella vita di una donna, rafforzando la percezione che chi non la viva in questo modo possa essere una cattiva madre. L’anticonformismo, lo spirito critico e la conoscenza profonda di se stesse durante la genitorialità diventa così una lettera scarlatta, non un monito per sperimentare un modo diverso di essere genitore in un’era dove, da equilibriste appunto, siamo funambole mentre ripensiamo al baricentro della nostra vita come donne.
Per alcune di noi per esempio non c’è niente di “cool” nella gravidanza, sfatando ciò che disse solo pochi mesi fa Lavinia Mennuni, parlamentare FdI. La maternità è una fase della vita che alcune abbracciano e come tale va normalizzata, non imposta come un dovere nazionalistico o esaltata. Normalizzata vuol dire renderla alla portata di tutti, come scelta sostenibile e sostenuta dallo Stato italiano, sul posto di lavoro così come nella vita di tutti i giorni: è la perdita di civiltà che scoraggia le nascite, non il femminismo. È il dover spiegare alla tua capa, per esempio, che non si possono mandare le mail di domenica alle 22.30, perché in quelle ore potresti avere una famiglia di cui prenderti cura o in generale una sfera personale che non dev’essere invasa fuori dagli orari di lavoro. È quel principio per cui ai colloqui di lavoro non si può chiedere se si vogliono avere figli o depennare dalla selezione del personale chi potenzialmente vorrebbe averli.
Normalizzare la gravidanza vuol dire anche demistificare il fenomeno delle “mamme pancine”. Non c’è nulla di “eroico” nel creare una persona, questo però non vuol dire che bisogna appiattire o dimenticare le difficoltà di una donna mentre tenta di realizzare il processo di transizione verso la maternità. In Italia non c’è alcun equilibrio sul concetto di “mamma”: o sei un angelo del focolare che i Pro Vita possono liberamente strumentalizzare contro la causa femminista, oppure sei una zavorra che rallenta la produttività del sistema capitalistico. La cosa grave è che purtroppo questa visione duopolistica la ritrovi anche in chi ti circonda. Così tu, mentre aspetti un* bambin*, ti ritrovi privata di comprensione a tutti i livelli, da quello istituzionale a quella più prossima. Succede così che se sei un Millennial, come nel mio caso, e la tua generazione come forma di ribellione ha infagocitato il mantra antiborghese che “con gli stipendi attuali, il precariato e la mancanza di politiche di welfare non si possono avere figli”, quando qualche tuo coetaneo cerca di uscire fuori dagli schemi, pensare al proprio futuro e crearsi una famiglia, molti iniziano a percepirti come una minaccia per la loro comfort zone ideologica. Succede che smettono di coinvolgerti nelle uscite di gruppo, che silenziano il buonsenso della comprensione e per ansia (o invidia) sociale si allontanano.
In un’era in cui abbiamo un bisogno bulimico di condivisione pubblica della nostra vita per guadagnarci l’approvazione degli altri, in cui tentiamo di fare marketing su noi stess* arrivando anche a mentire o appiattire i nostri desideri più intimi, come ho fatto anche io, in questi nove mesi oltre a dover ottimizzare le mie energie per generare un bambino, una parte delle mie forze l’ho dovuta razionalizzare per digerire alcune delle frasi più ottuse e insensibili che potessi mai trovarmi ad affrontare sulla gravidanza. E la maggior parte, mi spiace ammetterlo, venivano da donne. Molte di queste sono state pronunciate da persone che si tacciavano di essere femministe, che rivendicavano di aver partecipato attivamente a Pride, a dibattiti e cortei sull’inclusività, voci autocelebrative di “donne forti”, emancipate e che tentano di ritagliarsi un fazzoletto di utilità sociale piazzandosi all’occorrenza sotto i riflettori, ma che fuori dall’idealizzazione hanno finito per sbrindellare le loro idee nella totale superficialità della loro condotta. Per questo motivo ho maturato in questo periodo un’avversione totale per le attiviste da smartphone e la sorellanza di facciata. Non c’è niente di più meschino di una donna che si crede utile all’autodeterminazione di genere ma che si scontra contro il frangiflutti dell’ipocrisia e della banalità intellettuale.
Ho deciso di “proteggere” la mia fragilità e di non comunicare a tutti cosa mi stava succedendo in questi lunghi mesi di gravidanza. Ho condiviso invece la volontà di riscattarmi dalle aspettative sociali, di sentirmi libera di vivere e comunicare la mia gravidanza solo alle persone con cui mi sentivo connessa, per oppormi al leitmotiv “in genere si fa così”. Una frase fatta in cui la parola “genere” ha un significato ambivalente, un boomerang semantico e una prigione esistenziale: “comunemente si usa fare ciò” o “le convezioni di genere stabiliscono che questo modo di comportarsi sia quello maggiormente accettato dalle tue/dai tuoi simili”. Ma se la gravidanza si conforma in una dimensione personale, per quale motivo avrei dovuto appiattire la mia percezione, libera e indipendente, di questa esperienza per sottometterla a uso e costume del pensiero comune?
È la domanda che mi sono posta mentre aspettavo e che mi accompagnerà in futuro con mio figlio, nella ricerca di un nuovo equilibrio tra vita personale e professionale, nel tentativo di ridisegnare i confini della mia persona dopo questo tumultuoso momento della mia vita. Come donna, ma prima di tutto come persona.
Io e mio figlio non abbiamo nessun dovere nell’assecondare le aspettative verso la società: quando ci sentiamo dire che “ormai si vedono poche pance in giro” o “che siamo rimaste in poche a voler mettere su famiglia”, non mi sento un’eroina, non si innalza in me nessun moto patriottico e tantomeno mi sento la prescelta per proseguire la “razza italica” come in un film di fantascienza o in un documentario dell’Istituto Luce. Provo al contrario un moto di rabbia, perché quasi sempre a pronunciare queste frasi sono persone che ci hanno lasciato un paese sgozzato dai suoi diritti fondamentali. Persone che, a sinistra, non hanno combattuto abbastanza per rendere l’Italia odierna un paese a misura di donne; a destra, cittadine o cittadini che si sono fatti lobotomizzare da una classe politica che oggi siamo noi a subire come un trauma intergenerazionale.
Siamo noi, generazione da “1.000 euro al mese” se ci dice bene, a dover andare in terapia per purificarci di tutto il pattume ideologico che i nostri genitori e antenati non solo hanno accettato passivamente per anni, ma che hanno continuato a criticare mentre sgranocchiavano noccioline e olivette davanti al tubo catodico. Una contestazione fatta a spallucce, tramandata a suon di “ai miei tempi” e corredata di un pietismo fastidiosissimo. Per sentirci dire che, ahimé, oggi non si fanno più bambini, che le donne sono presuntuose e, peggio ancora, che “gli uomini non sono più quelli di una volta”. Forse perché le madri che dovevano crescerli hanno pensato più ad allevare dei cuccioli che dei cittadini utili al progresso del Paese. Quegli uomini mai sbocciati, ora, li dobbiamo azimare noi, rincuorarli sul fatto che la società che era stata raccontata dalle loro mamme ora non c’è più, che il loro senso di inadeguatezza è comprensibile ma non giustificabile e tutta una serie di paturnie di cui, grazie madri, grazie nonne, non possiamo che ringraziare solo e soltanto la vostra mancanza di attivismo storico-sociale. Per non parlare del ruolo dei padri, ovviamente, perché le responsabilità sono sempre ripartite certo.
Ed è per questo che sono fiera di aspettare un maschio: avrò l’opportunità di educare una persona a imparare un nuovo modo di comunicare ed entrare in contatto con l’immaginario femminile. Ho scelto di avere un bambino quando sentivo di esserne in grado e sentivo di avere accanto a me la persona giusta. Non banalmente quella che amo, ma quella che so metterà al mondo un figlio con la mia stessa visione del mondo. Ed ecco perché, quando parla di “noi”, il mio compagno usa una frase che sposo in pieno: “ci siamo scelti a vicenda”. Questa consapevolezza ha fatto sì che gran parte del processo di accettazione del mio stato “interessante”, nel momento in cui ho appreso di essere incinta, sia stata la parte più facile di tutta la gravidanza che sto portando a termine. Non c’è dubbio che questo bambino, che cresce forte in me ed empatizza con me e con la stessa intensità con suo padre, sia voluto e amato. Se ora mi trovo a scrivere è perché, contro mia ogni aspettativa, dentro di me non è maturato solo un bambino, ma l’amara presa di coscienza che se in Italia non si mettono al mondo abbastanza figli il problema è solo ed esclusivamente di una società che non sa accoglierli. Indipendentemente dalla casacca politica.
Non faccio riferimento allo spauracchio socioeconomico dietro cui si nasconde la mia generazione: il problema fondamentale del perché i miei coetanei non vogliono più crearsi una famiglia è che non sono in grado di avere relazioni sane ed equilibrate con le persone. La maggior parte di questa sterilità emotiva non viene solo dagli uomini, non è questa la versione della storia che porterà a guardarci dentro: le più grandi nemiche della fertilità femminile dobbiamo avere il coraggio di ammettere che spesso siamo noi donne. In Italia non si fanno più figli perché molte donne non hanno più il coraggio di farsi una sana autocritica sui loro obiettivi personali e sulle strategie con cui li perseguono, non hanno più il coraggio di staccarsi da quella stampellina sociale per cui si sentono in “dovere” di guadagnarsi l’approvazione del/della partner, di un padre o dei datori di lavoro come fine ultimo dei loro percorsi di vita, senza capire se siano imposti dall’alto o abbracciati come ragione d’esistere.
Prima che questa mia affermazione sia stravolta, voglio però mettere a fuoco il nocciolo della questione. Le attuali condizioni in cui “sopravvivono” le persone della mia età sono effettivamente insostenibili per crearsi una famiglia, dalla precarietà lavorativa, alle misure di welfare inconsistenti, una politica miope che non capisce minimamente quali siano le reali necessità di questo Paese. Sono tutti tasselli di un mosaico che ormai conosciamo bene e che purtroppo crocifigge ogni slancio di autodeterminazione delle donne.
Queste però sono le cause a monte del problema, non le aggravanti. Il danno maggiore sta nel fatto che di fronte a una tale, lucida, conoscenza del problema, molte donne abbiano rinunciato a essere rivoluzionarie. C’è una visione “distorta” e una narrazione romantica della gravidanza che per mesi ho dovuto metabolizzare: una corrente racconta la gravidanza con una connotazione sognante, come se mettere al mondo un figlio fosse un’esperienza esclusiva ed escludente, il fine ultimo di una donna. Questa teoria ha finito per strappare alle donne la possibilità di immaginarsi diverse, di ricercare al di fuori del concepimento e del nucleo famigliare dei progetti di cui sentirsi artefici, delle ambizioni di cui sentirsi un “utero ideologico”. Ha sottratto agli uomini la possibilità di scoprire la genitorialità slegata dalle madri, di non sentirsi solo “funzionali” alla nascita ma di crescere emotivamente come padri, di connettersi con le proprie fragilità, paure, insicurezze e di avere la libertà di potersi scrollare di dosso la percezione di “maschio alfa” che tendenzialmente ci si aspetta da un padre di famiglia. C’è poi un’altra narrazione distorta della maternità che tende a “standardizzare” la gravidanza: nel tentativo di naturalizzare quest’esperienza e di sfatarne i tabu casa-lavoro, si tende all’estremo opposto a ignorare i bisogni delle donne. Così se disgraziatamente lascio in ospedale un posto a una signora inferma, mi sento rispondere da un’altra che “alla fine sono incinta, non disabile”, come se ci fosse una gerarchia di fragilità per cui io debba non abusare di un mio diritto. Così come mi sono trovata a dover spiegare a quelle che ritenevo amiche che se chiedo loro di aspettarmi all’uscita della metro non è perché non sia in grado di percorrere quel tratto di strada da sola col pancione, ma perché è un atto di gentilezza condividere un’esperienza insieme e farmi sentire al sicuro.
È stato umiliante in questi mesi dover spiegare che anche se sono una persona autosufficiente, ho bisogno di vicinanza emotiva, ho bisogno anche io di una parola di vicinanza o di una voce amica. Alla fine sono riuscita ad affrontare questo momento da sola, avvalendomi di pochi ma consolidati rapporti nutritivi, ma per il resto sono circondata da donne spesso insoddisfatte della loro vita, senza che ne capiscano il motivo.
In definitiva, mettere al mondo dei figli in Italia vuol dire rimanere soli. Una solitudine che non c’entra nulla con quella personale: dal momento in cui aspetti un bambino smetti di essere una persona e diventi automaticamente un “nucleo” o una “camera gestazionale” nel caso tu sia single. Nel primo caso i bisogni sono uniformati, dimenticati o dati per scontati in funzione della scelta che entrambi i genitori hanno fatto. Questo succede perché viviamo in una società che attribuisce automaticamente alla famiglia un’etichetta di sana prevedibilità. La mia generazione è quella che più di tutte vive la genitorialità come un conflitto interiore tra scelta e sacrificio. Ma perché dev’essere così, soprattutto se voluta?
Si dà per scontato per esempio che un padre sia invisibile di fronte a migliaia di persone che chiedono alla mamma come va una gravidanza, dimenticandosi dei suoi sentimenti, del suo stato d’animo e delle sue paure, talmente è dato per certo che sia lui a doversi prendere cura dell’altra. All’uomo è chiesto di stare un passo indietro in un momento della propria vita in cui madre e padre compartecipano invece allo stesso modo: in cui vivono le stesse paure, ma con modalità diverse.
Così come nessuno si ponte mai il problema di quanto sia soffocante per una mamma convivere con chi parla solo ed esclusivamente di quanto sarà difficile rinunciare a se stesse. A volte si parla troppo, a volte non si parla per niente: il risultato è un vuoto emotivo che lascia completamente inascoltati i futuri genitori anche in mezzo a interi gruppi di persone.
Bisognerebbe solo trovare le parole giuste, ma in questo mondo dove si dà più valore a un “like” a una storia che a una chiamata, sottovalutiamo quanto un minuto delle nostre giornate sia importante per gli altri. È uno sforzo troppo grande per le persone concepire che quelle parole possono essere un grande aiuto per chi sta cercando di accettarsi, mentre tenta di costruire la propria dimensione genitoriale. Ciò di cui non si parla mai è quell’esclusione sociale che fa male, che lascia da soli donne e uomini in un momento di grande fragilità per entrambi. È quello scatto automatico per cui si dà per scontato che due persone che aspettano un figlio non abbiano più bisogno di nient’altro che dell’altra metà. È una visione insana delle relazioni di cui si parla tutti i giorni, ma all’atto pratico anche i nostri coetanei non fanno nulla per contrastarla.
Quel ragionamento autoconclusivo per cui ci si risponde che due genitori non vengano inclusi perché hanno “da fare” anziché ammettere che non c’è spazio per le famiglie. Vale nel dibattito pubblico, così come negli spazi sociali di questo Paese. Ed ecco perché non c’è solo un modello di genitorialità, non ci sono risposte univoche e anche l’essere genitori include un modo diverso di relazionarsi agli altri. La domanda è: siamo davvero dispost* a mettere in discussione le nostre rigidità mentali? È anche dovere di chi ci sta accanto capire quando madri e padri sono prima di tutto persone, non solo “gestanti”, e abbiano bisogno di essere vist* e percepit* più che come sagome per alzare l’indice di natalità, come categorie fragili. Se si vuole una società sostenibile, che permetta alle future generazioni di crescere e responsabilizzarsi, sarebbe corretto partire quantomeno da se stess* e includere in ogni frangente della propria vita, pubblica e privata, chi tenta ogni giorno di superare i preconcetti sulla genitorialità. Andando in controtendenza, col rischio di essere sol*, ma almeno assecondando quei progetti su cui l’opinione pubblica finge di credere.