PARTE 1. NUOVI TERMINI, ANTICHE QUESTIONI: IL POTERE POLITICO DEL LINGUAGGIO
La recente presa di posizione di Roberto Saviano sul tema della necessità di regolamentare ‘in positivo’ il lavoro sessuale (“l’approccio alla prostituzione è paternalistico, focalizzato su come si dovrebbe vivere con annesso giudizio morale, piuttosto che sul provare a regolamentare una professione ancora oggi stigmatizzata”) ha riacceso il dibattito sul tema. Il confronto che dovrebbe coinvolgere i soggetti protagonisti di questa questione sociale spesso – ancora oggi – li utilizza come oggetto astratto e intangibile su cui proiettare la propria morale o le proprie preoccupazioni.
“Troppi pensano non si tratti di un lavoro”, come tempo fa aveva osservato Susanna Camusso rispetto alla prostituzione e in occasione dell’iscrizione di una ballerina di lap dance e delle sue colleghe alla CGIL: “troppi […] bollano tutto questo mondo come deviato e colpevole. In genere non si interrogano sul mercato che lo determina, ma giudicano chi ci lavora. Siccome lo condannano, in nome della loro morale, non riconoscono che sia lavoro e non si interrogano sulle caratteristiche e le condizioni”.
Questo approccio stigmatizzato da Camusso ha portato alla totale esclusione, perpetrata nel tempo, delle sex workers da qualsiasi discorso occupazionale trattandosi di una professione non convenzionale che rompe i nostri schemi mentali, facendo breccia in una morale sessuofobica più o meno latente che, molto spesso, non realizziamo nemmeno di conservare gelosamente in noi. “Penso – continuava Camusso nell’articolo per Collettiva.it – sia importante, oltre che giusto, che le lavoratrici siano state accolte in Cgil, sulla base di quello che deve essere per noi il principio irrinunciabile: una persona che lavora ha diritti e tutele, deve avere un contratto e accesso alla contrattazione collettiva, ha diritto a rappresentare ed essere rappresentata. Ad ogni lavoro, cioè, va riconosciuta dignità e nessun pregiudizio può cancellarla”.
Ad ogni lavoro appunto, perché parliamo di lavoro quando parliamo di sex work: utilizzando la definizione fornita da Giulia Zollino – antropologa, esperta in educazione sessuale, con lunga esperienza nelle unità di strada e sex worker – e che ritroviamo nel suo saggio “Sex work is work” realizzato per Eris Edizioni, possiamo descrivere il lavoro sessuale come una “qualsiasi attività che prevede un accordo commerciale esplicito tra due o più parti, con il quale si stabilisce una retribuzione economica in cambio di un servizio sessuale/erotico/romantico concordato e limitato nel tempo”. Il termine sex work va, dunque, immaginato come un ombrello che racchiude in sé diverse tipologie di attività fra cui il lavoro indoor offline (appartamenti, night club, centri massaggi), outdoor (in strada), ma anche la pornografia, la vendita di contenuti audiovisivi o di intimo usato, le cam, le linee erotiche e tanto altro.
L’intero saggio di Zollino è dedicato alla rivendicazione del lavoro sessuale in quanto lavoro, che deve prevedere “diritti e tutele per le persone che lo esercitano. […] Lo stigma mi fa paura, ma ho fatto una scelta politica e ho scelto di usare il mio privilegio per trasmettere un messaggio. Nella discussione sul lavoro sessuale le persone che fanno sex work non sono quasi mai protagoniste, ma compaiono piuttosto come oggetti di studio”.
Ma perché parlare di sex work, oggi, e non più semplicemente – e come comunemente avviene – di prostituzione? “Prostituta, puttana, meretrice, lucciola, peripatetica, zoccola. I termini impiegati nel corso della storia per descrivere il lavoro sessuale e le persone, soprattutto donne, che lo esercitano sono molteplici ed esprimono un giudizio morale preciso” osserva Zollino per introdurre una breve spiegazione proprio sul perché oggi si parli di sex work e del portato politico di questa espressione.
Il termine ha le sue radici nella prima conferenza sul tema della prostituzione organizzato nel 1978 dal collettivo femminista anti-porno Women Against Violence in Pornography and Media. Per quell’occasione Carol Leigh – meglio conosciuta come The Scarlot Harlot e “puttana ostinata” – propose di intitolare un panel “Sex Work Industry” invece di “Sex Use Industry”, come volevano le organizzatrici. L’espressione sex work raggiunge, poi, l’Italia qualche anno dopo, nel 1994, quando Pia Covre – fondatrice con Carla Corso e presidente del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute – indice una riunione con le colleghe sex workers, in occasione della quale viene abbandonato definitivamente il termine ‘prostitute’: quello che essenzialmente si rivendica è la fondamentale libertà di nominare la propria esperienza.
Oggi questa rivendicazione si è estesa anche alla parola “puttana”, principalmente all’interno dei movimenti spagnoli e latino-americani: in una intervista realizzata proprio da Giulia Zollino a Georgina Orellano, segretaria generale di AMMAR – Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina – viene raccontata l’opera di riappropriazione dell’insulto e del suo accoglimento come identità politica: “tutto il linguaggio è politico – racconta Orellano – e abbiamo capito che già avevamo regalato troppo al patriarcato e continuare a regalargli le nostre parole, le nostre identità, ci fa retrocedere”.
Se però il linguaggio ha un potere politico, parlare, come abbiamo fatto fino ad ora, di sex workers esclusivamente al femminile è un ulteriore stereotipo; difficilmente, infatti ci ricordiamo che le identità di chi pratica sex work sono tanto varie quanto quelle di chi incontriamo ogni giorno in ogni luogo, essendo svolto sia da persone cisgender – uomini e donne – sia da persone transgender – ancora, uomini e donne. Ci hanno insegnato ad usare istintivamente la parola ‘prostituta’ e ad usarla al femminile – a concepire chi lavora come sex worker come una donna in abiti succinti e tacchi che passeggia lungo il bordo della strada.
I nostri occhi si spalancano alla declinazione della parola al maschile, che pure la Treccani riconosce come linguisticamente non comune. Succede quando né la nostra lingua né l’immaginario usano la parola “prostituto”, negando quindi un portato, un’identità e una esperienza; all’orecchio ricorda quel tedioso e ridicolizzante ‘mammo’ usato spesso dalle testate giornalistiche e che riecheggia l’essere a prestito in un ruolo canonicamente non maschile, ma che nella realtà – quello del genitore e del sex worker – si dimostrano come tanto femminili quanto maschili.
Il dibattito anche in Italia comincia faticosamente ad aprirsi, ed è un bene che lo sia. Ma nel 2022, come per molti temi affrontati dal femminismo moderno, il confronto non può seguire le tracce del già detto e già ascoltato, senza alcun passo avanti, né presa di coscienza di realtà che oggi esistono, e che proveremo a raccontare nelle puntate successive di questo articolo. Perché ancora prima di costruire trincee bisognerebbe chiedersi cosa vuol dire oggi andare fino in fondo oltre gli stereotipi che riguardano il sesso.
Foto di Sally T. Buck by flickr
Red Umbrella March for Sex Work Solidarity. 2016 – Vancouver, BC, Canada
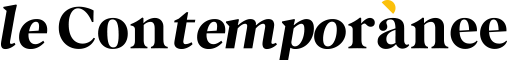



Una risposta
Giuste considerazioni perchè in effetti si sente la mancanza di un discorso femminista che sia non solo adeguato alla realtà attuale ma anche espressione di possibili concreti disegni politici non ideologici e stigmatizzanti che alla fine risultano contro le libertà e i diritti delle donne.