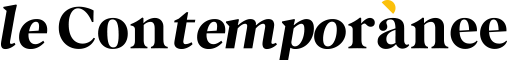Nella sua analisi, dal titolo “La CSE (Comprehensive Sexuality Education – educazione sessuale completa) a scuola: storia, diritto e scienza a confronto“, Mila Spicola pone in luce le profonde criticità connesse al divieto dell’educazione alla sessualità, sino alla scuola secondaria di primo grado.
Il recente emendamento presentato dalla Lega e approvato in Commissione Cultura alla Camera introduce un divieto sostanziale di attività didattiche e progettuali su temi “attinenti all’ambito della sessualità” nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, demandando l’eventuale trattazione alle sole secondarie di secondo grado e comunque previo consenso informato scritto delle famiglie, con controllo preventivo su temi e materiali. La misura, con validazione politica a livello parlamentare, ha innescato un conflitto pubblico non marginale, perché va ben oltre una disputa curricolare: ridefinisce i confini tra scuola e famiglia, restringe l’autonomia didattica (https://milaspicola.medium.com/il-divieto-delleducazione-sessuale-e-affettiva-12987baace8e ), norma il linguaggio sul corpo e sulle relazioni in età evolutiva.
Non siamo dinanzi ad un episodio estemporaneo. Il dispositivo di legge italiano s’iscrive in una traiettoria transnazionale promossa dalle destre estreme e sovraniste, che hanno reso l’attacco all’educazione sessuale e relazionale un perno identitario.
A convergere sono due assi ideologici.
Il primo è una sostanziale omofobia/transofobia in variante bio-essenzialista: l’idea che “esistano solo due generi” e che l’educazione inclusiva sia un’“ideologia” capace di confondere i minori.
Il secondo è il controllo politico sul corpo delle donne: dalla limitazione dell’accesso a informazioni riproduttive, fino al ridisegno simbolico della sessualità come affare privato e moralmente vigilato.
Ciò che viene presentato come “diritto dei genitori” funziona in realtà da clava per sottrarre alla scuola — luogo pubblico della conoscenza — la possibilità di formare linguaggi, consapevolezze e criteri critici su identità, relazioni, salute.
La Comprehensive Sexuality Education (CSE): cos’è
Nel merito empirico e giuridico, la letteratura internazionale e le norme europee convergono nel considerare la Comprehensive Sexuality Education (CSE) una componente essenziale del diritto della persona, in particolare il diritto all’istruzione e alla salute. La CSE è definita come percorso integrato e basato sui diritti che connette dimensioni biologiche, cognitive, emotive, relazionali e sociali; non si limita alle informazioni sull’apparato riproduttivo né alla sola prevenzione sanitaria, ma affronta consenso, rispetto, parità, stereotipi, violenza, orientamento, identità, benessere (OMS Europa/BZgA, Standards for Sexuality Education in Europe, 2010: https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2016/06/WHOStandards-for-Sexuality-Ed-in-Europe.pdf WHO-Europe; UNESCO International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach, Revised Edition, 2018 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770 ). In questi documenti e nella letetratura scientifica la scelta dell’aggettivo “comprehensive” non è retorica: l’efficacia dipende dalla completezza dei contenuti e dalla loro progressione per età; spezzare o censurare blocchi tematici ne indebolisce l’impatto preventivo e formativo
Sul piano degli esiti, le evidenze mostrano che la CSE non anticipa l’inizio dei rapporti sessuali (dubbio espresso a volte dalle famiglie contrarie alla sua introduzione), ma accresce condotte responsabili, riduce gravidanze indesiderate e IST, migliora la capacità di riconoscere e segnalare abusi, e contribuisce alla prevenzione della violenza di genere. Anche in Italia, laddove progetti strutturati sono stati realizzati in integrazione con i servizi sanitari, i risultati sono coerenti con il quadro internazionale.
La cornice normativa europea
La Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 su salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti sancisce che l’educazione sessuale completa (CSE), scientificamente corretta, basata sulle evidenze e adeguata all’età debba essere accessibile a tutti i bambini e adolescenti, dentro e fuori la scuola. Invita gli Stati a rimuovere barriere giuridiche, politiche e finanziarie e a garantire servizi e formazione docenti coerenti con gli standard OMS (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_EN.html ).
La Convenzione di Istanbul — ratificata in Italia con legge 77/2013 — richiede, inoltre, che i curricoli promuovano l’uguaglianza di genere e la prevenzione della violenza, includendo competenze relazionali e di rispetto reciproco (Testo ufficiale della Convenzione di Istanbul sul sito del Consiglio d’Europa: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-the-convention ; Dossier della Camera dei Deputati sull’attuazione della Convenzione in Italia: https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pd ).
La cornice normativa italiana
Se passiamo alla storia italiana, la traiettoria rivela un paradosso. Con la Legge 405/1975 lo Stato istituiva i consultori familiari attribuendo loro funzioni di informazione e educazione sulla procreazione responsabile e sulla sessualità, anche in collaborazione con le scuole: un’impostazione pionieristica nel collegare sanità pubblica, prevenzione e formazione (art. 2, lett. b-c: Normattiva, 1975). La 405/1975, dunque, riconosceva, ed eravamo tra i primi paesi europei a farlo, l’educazione sessuale come servizio pubblico e preparava il terreno per progettualità scolastiche territoriali. Questo aspetto di quella legge fondamentale, tutt’ora in vigore, viene spesso trascurato, ed è ignoto ai più.
Tuttavia, la mancata istituzionalizzazione curricolare e, più tardi, il declino dei consultori in molte aree del Paese hanno reso l’offerta intermittente e diseguale, spesso lasciata all’autonomia e alla disponibilità dei singoli istituti, e con questo anche il fondamentale contributo informativo e educativo da essi chiamato a svolgere secondo la legge e che hanno svolto quando hanno potuto.
Il recepimento progressivo di standard e impegni internazionali ha avuto tappe importanti: la ratifica della Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) si è sostanziata nell’approvazione del decreto-legge sul contrasto alla violenza di genere (DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119) che ha previsto (art. 5) l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.
Il Piano d’azione – adottato con D.P.C.M. 7 luglio 2015 – ha inteso dare attuazione ad interventi che consistono nella valorizzazione dei progetti territoriali.
Tra le altre cose, la legge del 2013 – e il Piano d’azione conseguente – individuano le seguenti finalità (https://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0173.pdf ):
“a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l’adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
(…) “
Sui punti a) e b) le istituzioni in questi anni hanno fatto poco o nulla. Sul versante scuola, invece, qualcosa si è mosso.
Con la Legge 107/2015 – dopo feroci discussioni nel dibattito parlamentare e nel Paese – si introduce l’obbligo per le istituzioni scolastiche (l’obbligo, non la discrezionalità, l’obbligo:in attuazione della Convenzione di Istanbul e del Legge n. 119 del 2013 su citate) di inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola (PTOF) attività per la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza e di ogni discriminazione, con coinvolgimento della comunità educante.
Il principio, in linea con la cornice del Consiglio d’Europa e con gli standard OMS/UNESCO, e con le normative internazionali recepite dall’Italia, avrebbe potuto sostenere un’evoluzione verso forme stabili di CSE adattate per età.
Invece, complice una sostanziale incapacità delle forze di politiche e delle figure apicali ministeriali di agire con chiarezza, complice l’alternarsi di governi non particolarmente favorevoli alla direzione assunta dal nostro Paese di armonizzazione con i mandati internazionali e comunitari, complice l’assenza di documenti normativi nazionali vincolanti e finanziati e il, complice anche il depauperamento dei consultori pubblici – gli unici ad oggi deputati espressamente a fornire CSE con legge dello Stato ancora in vigore – rispetto agli standard di dotazione (1 ogni 20.000 abitanti previsti dalla L. 34/1996), l’educazione sessuoaffettiva (tradUzione italiana di CSE) è rimasta non strutturale, discrezionale e vulnerabile a oscillazioni politiche e pressioni locali, fino ad arrivare ad oggi in cui è espresso chiaramente un divieto.
È da ricordare comunque che il dicastero Fedeli, sotto il governo Gentiloni, era pronto a emanare linee guida e un piano specifico strutturale di azione, rimasto nei cassetti ministeriali con l’arrivo di governi successivi.
Eppure, la scienza, dal canto suo, da tempo documenta i benefici della CSE e ne prescrive la completezza.
L’attuazione della CSE in Europa
Nel panorama europeo, riguardo la Comprehensive Sexuality Education (CSE), riconosciuta come parte integrante del diritto all’educazione e alla salute, la maggioranza dei paesi membri dell’Unione ha adottato un quadro normativo o curricolare coerente con gli Standards for Sexuality Education in Europe richiamati in precedenza ed elaborati dall’OMS (OMS Europa/BZgA, 2010) .
Secondo il rapporto WHO Regional Office for Europe / Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Sexuality Education in Europe – Regional Overview: Status of sexuality education in 25 countries (2019-2020), in 21 dei 25 paesi esaminati esiste un quadro normativo (legge/politica/strategia) per l’educazione alla sessualità scolastica; di questi, in 11 paesi la CSE è obbligatoria per legge in tutte le scuole (https://whocc.bioeg.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_RegionalOverview_EN.pd ).
I modelli più avanzati di educazione sessuale e relazionale si trovano nei paesi nordici e dell’Europa occidentale, dove la CSE è parte integrante dei curricula scolastici e della formazione civica.
La Svezia è considerata il paese pioniere in materia: l’educazione sessuale è obbligatoria dal 1955 e da allora è
stata costantemente aggiornata per includere aspetti di genere, consenso e identità. Il sistema scolastico svedese prevede che tutti gli studenti, dalla scuola primaria in poi, affrontino la CSE come parte del curriculum nazionale. (Education Profiles – Sweden, Comprehensive Sexuality Education, UNESCO Global Education Monitoring, https://education-profiles.org/europe-and-northern-america/sweden/~comprehensive-sexuality-education; WHO Regional Office for Europe / BZgA, Standards for Sexuality Education in Europe, 2010, https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2016/06/WHOStandards-for-Sexuality-Ed-in-Europe.pdf )
In Finlandia, la CSE è stata introdotta a livello curricolare negli anni Settanta e oggi è integrata in tutte le fasi del percorso scolastico, dalla scuola primaria alla secondaria. Tutti gli insegnanti sono formati all’interno dei corsi universitari di abilitazione, che comprendono moduli specifici sull’educazione sessuale, affettiva e relazionale. (Education Profiles – Finland, Comprehensive Sexuality Education, UNESCO, https://education-profiles.org/europe-and-northern-america/finland/~comprehensive-sexuality-education; IPPF Europe, Factsheet Finland, 2018, https://europe.ippf.org/sites/europe/files/2018-05/Factsheets%20Finland.pdf )
Nei Paesi Bassi, dal 2012, l’educazione alle relazioni e alla sessualità (Relationships and Sexuality Education) è obbligatoria in tutte le scuole primarie e secondarie. Essa si fonda su un approccio olistico che intreccia benessere, rispetto e diversità, con percorsi formativi destinati anche ai docenti e sostenuti da fondi pubblici. (Education Profiles – Netherlands, Comprehensive Sexuality Education, UNESCO, https://education-profiles.org/europe-and-northern-america/netherlands/~comprehensive-sexuality-education; Rutgers Foundation, Sexuality Education in the Netherlands, 2022, https://rutgers.international/wp-content/uploads/2022/11/Sexuality-education-in-the-Netherlands-2022-Digitaal_LowRes.pdf )
Nel complesso, la Commissione Europea, nello studio Comprehensive Sexuality Education – Legal and Policy Frameworks (European Parliament, 2022), rileva che in molti Stati membri dell’UE la CSE è obbligatoria o fortemente raccomandata, ma che persistono importanti differenze nella qualità e nell’effettiva implementazione per quel che riguarda:
la formazione iniziale e continua del personale docente, ancora insufficiente in molti paesi;
la frammentazione dei programmi scolastici, che spesso non integrano la CSE nel curriculum generale;
la disomogeneità dei contenuti, soprattutto rispetto all’inclusione dei temi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
(Parlamento Europeo, 2022, Comprehensive Sexuality Education: Legal and Policy Frameworks, documento IPOL_STU(2022)719998, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/719998/IPOL_STU(2022)719998_EN.pdf ; L. Brockschmidt, O Ivanova , E Ketting, Educazione sessuale in Europa: una valutazione dello stato attuale, delle sfide e delle buone pratiche, European Journal of Public Health, 2022, https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement_4/ckz185.354/5624349 )
In sintesi, mentre i paesi del Nord e dell’Ovest d’Europa considerano l’educazione sessuale parte integrante della formazione civica e della salute pubblica, i paesi del Sud e dell’Est — Italia compresa — la trattano ancora come materia opzionale, spesso ostacolata da controversie ideologiche. Questo divario riflette non solo differenze politiche e culturali, ma anche un diverso grado di recepimento del mandato normativo europeo, che considera la CSE non un’opzione etica, ma un diritto cognitivo, sanitario e civile delle nuove generazioni.
In questo scenario, l’Italia si colloca nella fascia inferiore della distribuzione europea.
Il nostro paese dispone, come abbiamo visto, di un quadro legislativo che riconosce la necessità dell’educazione affettiva e sessuale, ma non ha mai sviluppato una policy nazionale vincolante né una formazione strutturata degli insegnanti. Come evidenzia, tra gli altri, anche il portale della Commissione Europea Creating Safe and Inclusive Schools for LGBTI Youth (2023), l’Italia è uno dei paesi in cui l’educazione sessuale non è obbligatoria e dipende fortemente dall’iniziativa delle singole scuole o delle amministrazioni regionali.
Conclusioni
In questo quadro, l’emendamento approvato adesso nel 2025, – recante, lo ripetiamo, il sostanziale divieto di attività didattiche e progettuali su temi “attinenti all’ambito della sessualità” nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, demandando l’eventuale trattazione alle sole secondarie di secondo grado e comunque previo consenso informato scritto delle famiglie, con controllo preventivo su temi e materiali – non è solo regressivo rispetto agli obblighi assunti in sede europea, ma contraddice sia i mandati normativi sia la razionalità delle politiche pubbliche fondate su prove ed evidenze scientifiche.
Infine, last but not least, trasforma l’autonomia scolastica in autonomia sorvegliata: la scuola non sceglie se e come educare su corpo, consenso, rispetto; è chiamata a non farlo, o a farlo tardi e con filtri autorizzativi famigliari che, di fatto, selezionano il diritto all’informazione. L’argomento “parental rights” diventa così un meccanismo di censura preventiva, volto a impedire l’alfabetizzazione affettiva proprio nelle età in cui si costruiscono linguaggi e competenze sociali di base
La dialettica fra i due assi ideologici menzionati — bi-essenzialismo omofobico e controllo del corpo delle donne — spiega la coerenza politica della misura: tagliare l’educazione sessuale dalla scuola significa sottrarre spazi pubblici di conoscenza alle soggettività minoritarie e femminili, ridefinendo la sessualità come fatto privato, moralizzato e gerarchico e vincolandolo a dettami ideologici e/o confessionali.
La scuola, istituzione costituzionalmente autonoma e presidio della libertà di insegnamento, viene sospinta a rinunciare a una funzione essenziale: formare cittadini capaci di linguaggio sul corpo e sulle relazioni, competenti nel consenso, vigili contro la violenza.
Riassumendo: la letteratura scientifica mostra dati sulla necessità e positività per quel che riguarda la prevenzione della violenza e la diffusione di comportamenti informati e corretti nelle relazioni tra i generi; OMS Europa e BZgA hanno definito standard per età; l’UNESCO ha consolidato un repertorio di risorse e riferimenti; il Parlamento europeo ha richiesto a tutti gli Stati di garantire accesso universale a informazioni e servizi; i progetti italiani in collaborazione con il Servizio sanitario mostrano che è possibile integrare scuola e sanità in modo virtuoso. Eppure stiamo dove stiamo.
In Italia, la riforma del 1975 ci ricorda che eravamo stati tra i primi a riconoscere istituzionalmente il valore educativo della sessualità come materia di salute pubblica. Ciò che è mancato è stata la seconda gamba: la strutturazione curricolare universale con la corrispondente sensibilizzazione e preparazione del personale educativo scolastico e dall’altra, per quel che riguarda l’approfondimento scientifico-medico-psicologico, l’attività effettuata da servizi territoriali adeguati – nello specifico indicati dalla legge nei consultori -, organici e ben finanziati. I numeri sui consultori attivi, inferiori come abbiamo visto agli standard di legge e con forti divari territoriali, spiegano perché la CSE fornita dal servizio sanitario pubblico prevista dalla legge n. 405/75 sia rimasta spesso episodica.
L’Italia rischia di stonare proprio sulla nota più elementare della cittadinanza: il diritto a conoscere il proprio corpo e a nominare le relazioni.
Il divieto, che, va detto esplicitamente, sottende i caratteri dell’omofobia, della transfobia e della misoginia e, come tale potrebbe essere oggetto di richiami in sede comunitaria, non “protegge i bambini”: protegge l’ignoranza, delegittima la scuola come luogo pubblico della conoscenza, relega la sessualità nel recinto privato e censurato. Non è un neutro aggiustamento amministrativo, ma un gesto programmatico: l’adesione a una strategia reazionaria che fa della paura del corpo e della differenza la propria grammatica politica.
In un Paese che ha istituito i consultori quasi mezzo secolo fa, la coerenza tra storia, scienza e diritto chiederebbe altro: CSE completa, per età, fondata su prove, nel perimetro dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, con un Servizio sanitario territoriale capace di sostenerla. Tutto il resto è una fragile retorica di controllo.