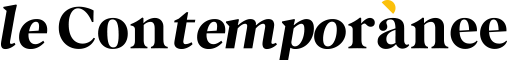Il carcere, per come lo conosciamo oggi, non assolve alla sua funzione costituzionale di risocializzazione e rieducazione del reo, prescritta dall’art.27. Alle porte delle città italiane vi sono strutture esclusivamente punitive, costruite in un’ottica di isolamento e allontanamento del ‘problema’. Lo spazio fisico e mentale sono insufficienti, una ulteriore condanna compressa in “3 metri quadri”, come recita il titolo del libro di Alessandro Capriccioli uscito di recente.
Date le premesse, il carcere – questo carcere – è inutile. Il primo passo di una riforma organica dovrebbe, quindi, muoversi verso la sua abolizione. Ma come farlo comprendere ai cittadini e alle cittadine del paese, immersi fra cronache giornalistiche e partiti giustizialisti che invocano vendetta per ogni violenza e violazione? Un’idea potrebbe essere quella di partire dalla ragionevole e possibile abolizione del carcere femminile che per numeri, costi e logica punitiva, non soddisfa alcun requisito di razionalità. Seguendo il ragionamento che proveremo a sviluppare in questo articolo, ci auguriamo che si comprenderà meglio come anche altri reparti carcerari possano essere superati adottando criteri simili.
Secondo i dati forniti dall’Associazione Antigone nel suo XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione, le donne detenute negli istituti penitenziari italiani al 31 marzo 2022 erano 2.276, pari al 4,2% della popolazione detenuta totale. Un dato che si è mantenuto sostanzialmente costante dal 1993 a oggi per una durata media della pena inflitta che oscilla tra i 3 e 4 anni. In generale sono le pene fino a 5 anni quelle che vengono più spesso sentenziate.
Se l’obiettivo principale che si persegue attualmente con il carcere è l’allontanamento dalla società, è importante riconoscere come questo risultato si potrebbe ottenere percorrendo anche altre strade, diverse da quella detentiva intramuraria, la quale dovrebbe proporsi come extrema ratio destinata a individui con attestata pericolosità sociale. Gli studi condotti sulle donne detenute in Italia, in Europa e dall’altra parte dell’Oceano dimostrano come nelle carceri femminili si trovino perlopiù recluse non violente, con scarsi livelli d’istruzione, segnate da un contesto di grave marginalità sociale che si riflette nei reati per cui vengono incarcerate (reati legati principalmente alla legge sulle droghe e a reati contro il patrimonio), con poche esperienze lavorative e spesso con storie personali caratterizzate da abusi. Di fronte a questa realtà complessiva è il caso di chiedersi: com’è possibile che il carcere riabiliti e risocializzi queste donne? La chiusura di interi istituti, e il conseguente trasferimento di risorse ad attività e percorsi in grado di ridurre la recidiva, non sarebbe una soluzione più adeguata per quel 4% dell’attuale popolazione carceraria Italiana?
La cultura di governo che guarda al carcere come unica soluzione possibile per rispondere alla richiesta di certezza della pena accomuna l’Italia e gli Stati Uniti, paese in cui si spendono più di 50 miliardi di dollari l’anno per i sistemi carcerari. La differenza è che questo dibattito, in molti stati americani, oggi sembra aprirsi, così come già avviene da tempo nel Regno Unito, con i sostenitori dell’abolizione del carcere femminile che propongono l’affido a comunità per le donne che hanno commesso reati senza violenza (la maggior parte) e la custodia in centri vicino alle famiglie per le (poche) altre. I più virtuosi esempi di attuazione americana dell’abolizionismo sono in Illinois e in Oklahoma. I risultati conseguiti da “Project Redeply”, un progetto finanziato con fondi di stato in Illinois, dimostrano che le donne che hanno commesso reati senza l’uso della violenza vengono trattate in modo più efficace (il che significa riducendo quasi a zero ogni prospettiva di recidiva) in comunità anziché in carcere. Dal 2011 al 2013 il progetto ha permesso a 1.376 condannate per reati non violenti di evitare l’ingresso in carcere. In Oklahoma, in cui l’80% delle donne detenute sono ristrette per reati non violenti, è nato il programma “Women in Recovery”, finalizzato a fornire un’alternativa a donne condannate per crimini legati all’alcolismo e/o alla tossicodipendenza attraverso progetti che includono trattamenti e assistenza familiare, ai quali le donne con bambini piccoli sono ammesse con priorità.
A suggerire ulteriormente come il carcere femminile tradisca gli obiettivi costituzionalmente sanciti – oltre che rappresentare un costo eccessivo se relazionato ai numeri della popolazione carceraria – si aggiungono i casi delle donne detenute con figli, che chiamano in causa il loro diritto a essere madri e il contestuale diritto dei figli a crescere con la propria madre in un ambiente che non sia quello carcerario. Al 31 marzo 2022, erano 19 i bambini di età inferiore ai tre anni che vivevano insieme alle loro 16 madri all’interno di un istituto penitenziario, la maggior parte di questi (8 su 19) sono ospitati nell’Istituto a custodia attenuata per madri detenute di Lauro.
La legge Finocchiaro del 2001 – entrata simbolicamente in vigore l’8 marzo – ha introdotto due nuovi istituti: la detenzione speciale domiciliare, che permette alle detenute madri di bambini di età inferiore a dieci anni di poter scontare la detenzione residua presso la propria abitazione o in altro luogo di cura, assistenza o accoglienza dopo aver espiato un terzo della pena in carcere, e l’assistenza esterna dei figli minori. La legge, tuttavia, ha introdotto anche condizioni di accesso alle misure detentive che riservano questi benefici a chi non presenti rischio di recidiva e dimostri la concreta possibilità di ripristinare la convivenza con i figli: condizioni che, considerando la grande incidenza di condanne per reati legati alla legge sulle droghe, hanno impedito a moltissime donne di accedere a questi strumenti.
Con la legge 62/2011 il Parlamento ha introdotto le case-famiglia protette e gli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Madri). Con l’introduzione delle case-famiglia il legislatore ha dimostrato di aver compreso la necessità di tutelare il rapporto tra genitori detenuti e figli minori, e di essere disposto a farlo anche al di fuori di una cinta intramuraria: l’esperienza, per quanto virtuosa, è sfortunatamente ridotta a due sole case-famiglia protette, a Roma e Milano, mentre il resto del territorio nazionale ne risulta completamente sprovvisto. Il deputato del Partito Democratico Paolo Siani, pediatra, ha presentato nell’estate del 2020 una proposta di legge finalizzata ad alleviare le gravi criticità relative alla situazione di madri detenute con figli incentivando la stipula di convenzioni con gli enti locali per promuovere la realizzazione di nuove case-famiglia protette, così da garantire un “adeguato sviluppo cognitivo ed emotivo e una partenza felice della vita”. L’Onorevole Siani aveva già sottolineato nel 2019 come l’ostacolo principale alla promozione del modello delle case-famiglia fosse di natura puramente economica, tanto che la stessa legge 62/2011 stabilisce che la realizzazione di case-famiglia non debba comportare ulteriori oneri per lo Stato. Secondo Siani sarebbe necessario intervenire ulteriormente sulla disciplina delle misure cautelari “eliminando ogni riferimento alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, contenuto nell’art. 275 c.p.p. Apportando piccole modifiche anche all’art. 285 bis c.p.p., si dovrebbe sancire il principio secondo cui mai un bambino potrà varcare la soglia di un carcere”. La casa-famiglia protetta dovrebbe dunque diventare lo strumento di elezione per l’applicazione della custodia cautelare nei confronti delle donne, e solo a fronte di esigenze di cautela particolarmente rilevanti il Giudice dovrebbe disporre la custodia cautelare in ICAM. Importante è notare come nella legge di bilancio per il 2021 siano stati stanziati 4,5 milioni di euro per le case-famiglia protette, nella speranza che questa misura possa favorire il funzionamento di tale strumento.
Tre miliardi e un milione di euro: questa la cifra riportata dal bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e spesa nel 2021. Una cifra che sembra battere ogni record negli ultimi 14 anni e che rappresenta il 35% del bilancio del Ministero della Giustizia. Come se non bastasse, di fronte a carceri sovraffollate di nuovi detenuti e di recidivi si pensa a costruirne di nuove, destinando all’edilizia penitenziaria una somma aumentata di quasi quattro volte in soli quattro anni, passando da 25,6 milioni a 127,3 milioni riportati nel bilancio del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Più posti, più detenzione continuano a essere le uniche soluzioni adottate nel campo della giustizia, mentre prosegue la mancanza di politiche basate su misure alternative e perciò ispirate a una logica riparativa anziché meramente retributiva.
La voce di costo più rilevante della gestione carceraria è da sempre quella per il personale che supera l’80%, ma solo il 5% di questa spesa è destinato alla sua formazione rendendo, perciò, evidente l’insufficienza dei fondi relativi a una adeguata preparazione del personale rispetto ad una modalità di trattamento del detenuto che sia consona ed in linea con la necessità di risocializzazione.
La disumanità, il sovraffollamento, la recidiva, tutto ciò che di più drammatico (e spesso anticostituzionale) avviene nel nostro sistema penitenziario si potrebbe affrontare radicalmente non soltanto trasferendo sul sistema di affidamento ai servizi sociali una parte consistente delle risorse oggi assegnate al sistema carcerario, ma anche riducendo il numero di detenuti per consentire la chiusura di molti istituti: solo attraverso questa misura, infatti, sarebbe possibile ridurre i costi fissi altrimenti incomprimibili, ovvero quelli destinati al mantenimento del personale.
Ci siamo soffermati sulla logicità del superamento del carcere femminile, ma il ragionamento può essere esteso a molto altro. A partire da alcune depenalizzazioni, ma non solo. È davvero il carcere – e questo carcere – la risposta corretta per i 375 minori inseriti nel circuito? Non sarebbe più responsabile il ricorso al sistema della mediazione penale? La mediazione è una delle punte di diamante del procedimento riparativo così come declinato dalla risoluzione ONU 12/2002 intitolata “Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters”. Fanno parte del procedimento riparativo tutti i metodi grazie ai quali la vittima e il colpevole collaborano tra loro per risolvere le questioni conseguenti al delitto, con l’aiuto di un facilitatore.
E ancora, a proposito di infermità mentale, secondo l’associazione Antigone la sfida dell’oggi è indirizzata all’abolizione del “bisogno di REMS (Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza)”: in quest’ottica si renderebbe necessario ri-adottare lo stesso approccio attento ai bisogni e alle condizioni della persona che ha portato all’eliminazione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in quanto quasi “due terzi della popolazione internata era in realtà dimissibile e veniva tenuta internata per inerzia o inattività delle istituzioni preposte”.
Ed infine, sempre a titolo di esempio, a fronte di un disinteresse istituzionale per il tema della disabilità in carcere, dimostrato non solo dalla scarsità di misure volte ad affrontare la situazione, ma anche dalle poche e difficilmente reperibili informazioni sullo stato delle strutture attualmente presenti sul territorio italiano, facciamo nostra la domanda posta da Damiano Aliprandi in un articolo per Il Dubbio: “il carcere è un ambiente adatto per far espiare la pena a un disabile, oppure c’è la necessità di trovare una misura rieducativa diversa?”
Stiamo parlando di un percorso opposto a quello che i governi hanno intrapreso negli ultimi anni, che nei fatti porterebbe al superamento, se non del “carcere” come istituzione, sicuramente di moltissime strutture carcerarie con la conseguente conversione delle risorse. Ma ciò sarà possibile solo superando l’attuale e radicata mentalità carcerocentrica.
Photo by Ye Jinghan on Unsplash